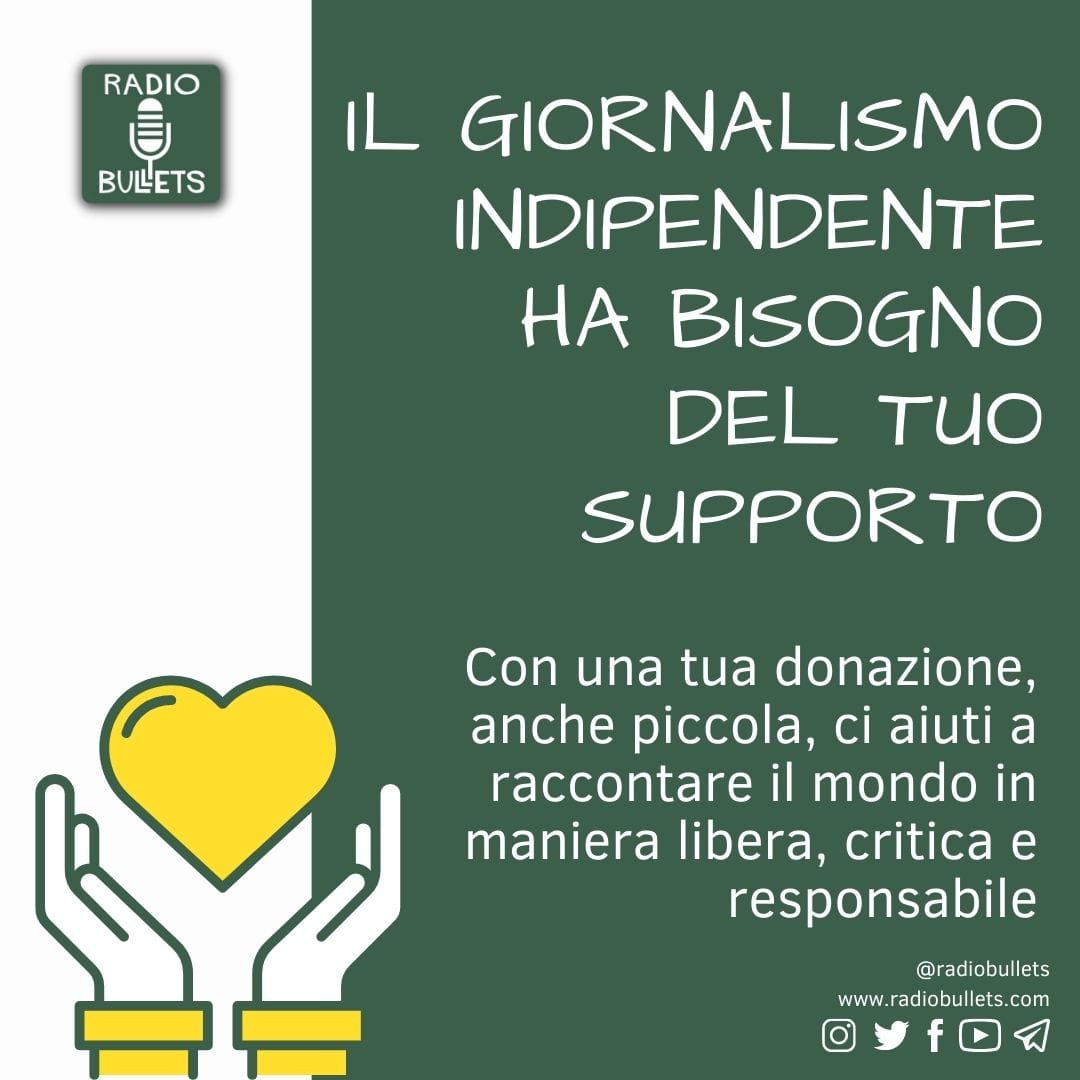1 agosto 2025 – Notiziario Africa
Scritto da Elena Pasquini in data Agosto 1, 2025
- Ghana: antichi conflitti rischiano di aprire varchi alla penetrazione jihadista
- Libia: si riaccendono le faide tra milizie a Tripoli
- Niger: la Russia punta all’uranio ex francese
- Congo: maxi-asta petrolifera minaccia foreste e popoli
Questo e molto altro nel notiziario Africa a cura di Elena L. Pasquini
“Le “nazioni” africane di oggi, create artificialmente dagli stranieri per i propri scopi, non hanno origine dall’antica civiltà africana, né si adattano al nostro stile di vita o alle nostre abitudini di scambio africane. Non sono nemmeno, per la maggior parte, economicamente sostenibili”.
Lo scriveva Kwame Nkrumah, primo presidente del Ghana, in Handbook of revolutionary warfare, sostenendo che l’ostacolo allo sviluppo dei Paesi africani fosse “l’imperialismo, principalmente nella fase neocoloniale”.
Ed è dal Ghana che iniziamo, dal Paese di Nkrumah, dai suoi confini, artificiose creazioni coloniali, Poi in Libia, nel caos di conflitti fratricidi solo all’apparenza lontani da un Occidente che continua a voler definire, credendosi non visto, la geografia dell’Africa.
Quindi, in Niger, dove un potere neocoloniale rischia di essere sostituito da un altro, a ameno che l’ex colonia francese non inizi a scrivere una nuova storia, e nella Repubblica democratica del Congo, dove la fame di energia minaccia ecosistemi tra i più preziosi della terra.
E infine in Sudan, per un fischio di speranza alla fine di un campionato che perpetua la storia del calcio africano, che da simbolo di oppressione si è fatto simbolo di resistenza. Oggi, 1 agosto 2025.
Ghana
Nel Nord Est del Ghana sono arrivati i soldati dopo che alcuni uomini armati sono entrati in un campus e hanno ucciso tre studenti di una scuola superiore nella città di Bawku lo scorso finesettimana.
Ucciso anche un capo locale, del gruppo etnico Kusaasi, nell’ennesima spirale di violenza in cui sta scivolando l’estremo nord di un Paese considerato tra i più stabili della regione.
Le tensioni sono salite e hanno “richiesto azioni drastiche”, ha affermato Felix Kwakye Ofosu, portavoce presidenziale: scuole chiuse, studenti evacuati, coprifuoco dalle 14 alle 6, regole stingenti per bloccare la circolazione dei motociclisti.
È un conflitto che dura da più di sessant’anni e che ha radici antiche quello che travaglia le terre che erano dominio del potente Regno dell’Dagbon. Oggi, queste terre rischiano di diventare la falla capace di trascinare anche il Ghana nell’instabilità in cui si dibatte il Sahel.
Il Dagbon giocava un ruolo importante nei commerci di oro, noci di cola, sale. Poi, quelle che fu il suo territorio venne diviso in due. Inglesi e tedeschi, odierni Ghana e Togo.
È in questo sembrarsi e ricompattarsi che vanno cercate le radici del conflitto che vede l’uno contro l’altro due gruppi, Mamprusi e Kusaasi, che si contendono il diritto di nominare il capo tradizionale di Bawuk.
La disputa risale all’epoca precoloniale, ma è nel secolo scorso che diventa scontro accesso, complice la manipolazione delle tensioni etniche che sempre ne fa il potere. Nessun governo, fino ad ora, è riuscito a sedarla veramente.
Siamo al confine con il Burkina Faso devastato dalla violenza di matrice islamista. “La minaccia proveniente dal Burkina Faso è seria e crescente. I militanti islamisti attivi lì hanno già causato milioni di sfollati, destabilizzando l’intera regione del Sahel.
Il confine settentrionale del Ghana con il Burkina Faso è permeabile, il che facilita il flusso di armi illegali, l’attività dei militanti e il movimento dei combattenti attraverso la frontiera”, scrive The Africa Report.
“Il Ghana è tradizionalmente considerato una democrazia stabile nell’Africa occidentale e il suo indebolimento nella parte settentrionale comporta rischi regionali più ampi”, aggiungono.
I gruppi che operano oltre confine potrebbero sfruttare, anche loro, le tensioni etniche, ma anche la crescente povertà che si accompagna all’escalation della violenza. La regione di Bawuk è sempre più povera, gli scambi commerciali sono interrotti, i mercati “collassati” per via degli “embarghi reciproci” che vietano ai gruppi etnici in conflitto di accedervi.
Gli attacchi prendono sempre più di mira la popolazione civile e la loro dinamica dimostrerebbe, secondo gli analisti, una crescente capacità organizzativa dei gruppi armati. Il traffico di armi, la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, poi, “è una vera e propria piaga”, come aveva detto alla radio locale Joy FM, Peter Toobu, ex ufficiale di polizia.
Queste condizioni, secondo gli esperti di scurezza, sono un terreno fertile per gruppi jihadisti “in cerca di nuove aree di reclutamento o di influenza”, come sottolinea ancora The Africa Report.
Libia
Con la mattina presto del lunedì, a Tripoli si riaccende la violenza fratricida, in una regione mai pacificata, in un Paese mai pacificato dalla fine del regime di Gheddafi, dove la lotta per il potere è lotta di milizie, notabili, famiglie, clan.
Ed è tra due famiglie, i Lefaa e gli Hadhwi, che è scoppiato lo scontro armato in cui è stato ucciso Ramzi Lefaa, comandante della Terza Compagnia, paramilitari fedeli al Governo di Unità Nazionale guidato da Abul Hamid Dbeibeh che controlla solo l’Occidente del Paese.
Sarebbero morti anche altri due membri della famiglia Lefaa e tre di quella rivale, secondo fonti della sicurezza riportate dal quotidiano The Libya Observer.
All’origine ci sarebbe stata solo una lite, capace qui, però, di innescare una spirale di violenza inarrestabile.
Lefaa aveva partecipato alle azioni di sicurezza che a maggio avevano condotto all’uccisione di Abdel Ghani Al-Kikli, capo di una temuta milizia nella Libia occidentale, l’Apparato di supporto alla stabilità, ma anche ad altre battaglie, a Tripoli, come nella sua città d’origine, nella guerra di potere con la Brigata 111 di Muammar al-Dawi.
Secondo quanto riporta Radio France Internationale, la tensione sarebbe salita quando un gruppo non identificato è entrato a Warshefana, nell’hinterland sud-occidente di Tripoli, nei quartieri controllati dalla Terza Brigata.
“Secondo diversi osservatori, con l’assassinio di tre influenti leader di milizie negli ultimi mesi nella Libia occidentale, si sta instaurando un nuovo equilibrio tra le varie forze”, scrive RFI. A causare questa ondata di violenza, proprio le milizie che dovrebbero garantire la sicurezza.
L’assassinio di Lefaa fa temere si possa tornare alle condizioni che hanno portato alla violenza di maggio, quando si sono scatenati gli scontri tra milizie e forze governative che hanno condotto alla morte di oltre 70 persone.
Una guerra di tutti contro tutti, di cui potrebbe approfittare Haftar, il generale che controlla la Cirenaica, l’”altra” Libia, quella che l’Italia non riconosce ma di cui addestrerebbe i soldati.
Secondo un’inchiesta del Post, i militari libici si troverebbero nelle basi del nostro Paese, che ufficialmente, però, riconosce come legittimo solo il governo di Tripoli, e di cui ugualmente addestra i soldati.
La lista civica “Una città in comune” di Pisa, che ha promosso un’interpellanza al Sindaco per chiarire la presenza dei soldati di Haftar nel Centro di Paracadutismo e nell’area di San Giusto, ricorda che a marzo del 2023 “investigatori indipendenti nominati dalle Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto che attribuisce alle autorità libiche e alle milizie armate, incluse quelle sotto il comando del generale Haftar, responsabilità per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
Tra cui detenzioni arbitrarie, torture, omicidi, stupri, riduzione in schiavitù e sparizioni forzate, documentando persino casi di schiavitù sessuale ai danni di migranti” e che “ il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite … ha rinnovato l’embargo sulle armi verso la Libia”.
Niger
Da decenni il vento del Niger porta con sé non solo sabbia e polvere, ma veleno, quello lasciato sulla terra dagli scarti della lavorazione dell’uranio. Da decenni l’acqua non disseta, ma intossica lì dove si scava.
Per decenni, l’estrazione di un minerale tanto prezioso per l’industria energetica dell’Occidente è stata nelle mani delle imprese francesi. Adesso il vento sembra voler girare portandosi via l’ex potenza coloniale, ma trascinando fino a Niamey la Russia.
Sergei Tsivilev, il ministro dell’energia russo è stato in Niger questa settimana. Insieme a lui, una fitta delegazione a rappresentare i colossi dell’uranio Rosatom e Rosgeo, insieme ad esponenti del ministero della Difesa.
La Russia dice di voler “sfruttare l’uranio” e sviluppare energia nucleare civile. “La nostra missione non è semplicemente quella di partecipare all’estrazione dell’uranio.
Dobbiamo creare un sistema completo per lo sviluppo dell’energia atomica pacifica in Niger. Ciò include la costruzione di impianti di generazione di energia per rendere l’elettricità accessibile a tutti i residenti del Paese, nonché la cooperazione nel campo della medicina nucleare.
Abbiamo anche concordato di formare congiuntamente specialisti in questo campo”, avrebbe detto Tsivilev, secondo quanto riporta l’agenzia Africain Initiative.
Una visita che arriva poco dopo la nazionalizzazione della Somair, la Société des Mines de l’Aïr, controllata dalla francese Orano, l’ex Areva, e della società elettrica Nigelec, da parte della giunta militare guidata da Abdourahamane Tchiani, salito al potere con un colpo di Stato nel 2023.
Il Niger, che vuole riconsiderare tutto il sistema delle concessioni minerarie a società straniere, ne aveva già preso di fatto il controllo, vietando le esportazioni ed estromettendo i francesi (ma anche i canadesi) dalla gestione di alcuni importanti giacimenti, a causa di “comportamenti scorretti”.
Non è valso a niente il tentativo dell’Orano di avviare azioni legali o di vendere le sue azioni.
Dall’incontro del 28 luglio, nulla è trapelato circa il destino dei siti dell’Orano o su un possibile passaggio di mano all’alleato russo, che sta occupando il vuoto lasciato dalla Francia anche nella lotta contro i gruppi jihadisti ai cui attacchi il Niger è sottoposto quotidianamente come i suoi vicini, Mali e Burkina Faso
Ad oggi ciò che è certo è soltanto quello che resta, in questo Paese dove l’uranio fu scoperto nel 1957 e sfruttato per la prima volta nella città di Arlit, nella regione di Agadez, nel 1971.
Resta, il sito di Dasa, gestito dalla canadese Global Atomic Corporation, e quello di Azelik, dove ci sono i cinesi, con la Société des mines d’Azélik (Somina).
Resta, soprattutto, la promessa di sun viluppo mancato e l’eredità di decenni di sfruttamento, quella che ci raccontava lo scorso anno un reportage di Marco Simoncelli per Irpimedia proprio dalla città di Arlit.
Un reportage che parla del prezzo pagato dalla popolazione, del tasso di mortalità altissimo per malattie respiratorie, delle falde acquifere inquinate, dei materiali di scarto lasciati in siti a cielo a aperto.
Che il vento cambi anche per chi abita e lavora dentro o ai bordi delle miniere, che si porti via il veleno che sporca la terra di chi produce per la nostra energia pulita, questa è una storia che deve essere ancora scritta e su cui in pochi sono pronti a scommettere.
La Repubblica Democratica del Congo
Il Governo della Repubblica democratica del Congo è pronto a mettere all’asta 55 blocchi petroliferi, terra destinata ad attività estrattive per circa 124 milioni di ettari.
Un nuovo rapporto, pubblicato da Earth Insight in collaborazione con Rainforest Foundation UK e le organizzazioni congolesi Our Land Without Oil e CORAP, racconta quanto grandi sono i rischi che il Congo, e il mondo, corrono grazie a questa espansione senza precedenti.
Alla fine del 2024 era stata annullata un’asta per 27 blocchi, fortemente contestata dalla società civile, poi il rilancio che minaccia la biodiversità, i diritti delle popolazioni indigene, il clima. I dati, come riporta Rainforest Foundation UK, sono impressionati.
“Mentre il governo della RDC afferma di aver risparmiato zone protette di alto profilo come il Parco Nazionale del Virunga dalla sovrapposizione diretta con i blocchi petroliferi, il rapporto rivela che si tratta di una cortina fumogena”, scrive Umar Manzoor Shah, su Inter Press Service.
L’attività estrattiva toccherà 8,3 milioni di ettari, il 23%, delle aree protette; 8,6 milioni di ettari di aree chiave per la biodiversità e 66,8 milioni di ettari, il 64%, di foreste tropicali intatte.
A gennaio di quest’anno, il governo aveva annunciato la creazione di un’area di conservazione grande quanto la Francia, 540.000 kmq, il ‘Corridoio verde Kivu-Kinshasa”, ma a leggere l’analisi dei ricercatori si scopre che anche quest’aree potrebbe non essere risparmiata: il 72% è allo stesso tempo potenziale terra d’estrazione.
Ma il rischio più grande lo corre uno dei luoghi più preziosi al mondo, le Cuvette Centrale, il più grande complesso di torbiere tropicali del pianeta, un pozzo che immagazzina, risucchia, circa 30 gigatonnellate di carbonio, più o meno l’equivalente delle emissioni globali in tre anni, come ricorda Manzoor Shah. “Gran parte di questo vitale ecosistema si trova ora all’interno di aree petrolifere di recente designazione”, dice il rapporto.
“Attività come trivellazioni, costruzione di strade e test sismici potrebbero prosciugare le zone umide, esponendo la torba ricca di carbonio all’ossigeno e liberando enormi quantità di CO₂ e metano nell’atmosfera”, scrive IPS. “Anche piccole alterazioni nelle torbiere possono innescare emissioni incontrollabili.
Se degradate, sono quasi impossibili da ripristinare entro tempi umani”, si legge nel rapporto. “Le torbiere sono ecosistemi estremamente importanti e le torbiere della Cuvette Centrale rappresentano uno dei più grandi pozzi di carbonio terrestri del pianeta.
È necessario adottare maggiori misure di salvaguardia per garantire l’integrità di questo ecosistema vitale e limitare le attività industriali”, ha dichiarato a IPS News Tyson Miller, Direttore Esecutivo di Earth Insight.
A rischio anche 39 milioni di persone, popoli indigeni, comunità forestali che vivono nelle aree destinate all’estrazione o nelle vicinanze dei giacimenti petroliferi. Rischiano di perdere ciò che permette loro di vivere, i mezzi di sussistenza, ma rischiano anche di veder scoprire le loro antiche culture.
“Inoltre, anche i blocchi petroliferi posizionati appena fuori dalle zone protette possono causare danni significativi. La costruzione di strade, lo sviluppo di oleodotti e la crescente invasione umana portano alla deforestazione, alla frammentazione degli habitat e a crescenti tensioni tra le comunità locali e le autorità preposte alla conservazione”, scrive ancora Manzoor Shah.
I congolesi, però, non restano a guardare, si mobilitano. La campagna “La nostra terra senza petrolio”, lanciata da una coalizione di organizzazioni congolesi, continua a raccogliere consensi.
“Immaginate: 39 milioni di congolesi, quasi la metà della popolazione, e il 64% delle nostre foreste potrebbero essere direttamente interessati dall’assegnazione di questi blocchi petroliferi “, ha dichiarato Pascal Mirindi, Coordinatore della Campagna di Notre Terre Sans Pétrole.
“Il bacino del Congo si sta avvicinando a un punto di svolta ecologico. Un’ulteriore frammentazione potrebbe trasformare le sue foreste da pozzi di carbonio a fonti di carbonio, innescando cicli di feedback climatici con conseguenze devastanti per il pianeta”, avverte il rapporto.
Un esempio di cosa può riservare il futuro, il Congo lo ha già davanti agli occhi, è la città costiera di Muanda, una delle regioni più misere del Paese, dove hanno sede le sue uniche attività petrolifere: “La popolazione locale soffre per l’inquinamento delle mangrovie, la diminuzione degli stock ittici e le malattie croniche, mentre i proventi del petrolio arricchiscono le compagnie straniere e le élite congolesi”, racconta IPS.
Il rischio, adesso, è che metà del Congo diventi come Muanda.
Sudan
Con una vittoria clamorosa, l’Al-Hilal ha vinto il campionato sudanese, la Sudan Elite League, grazie ai goal di Mohamed Abdelrahman, Walieldin “Pogba” Khidir, e alla doppietta di Abderraouf Yaacoub.
Ha travolto i rivali, l’Al-Merrikh, battendoli per 4 a 0. All’Al-Merrik sarebbe bastato un pareggio per aggiudicarsi il titolo e invece è finito secondo. Entrambe le squadre, però, combatteranno per portarsi a casa la Champions League africana.
A raccontarlo così sarebbe solo il drammatico e teso round finale di un qualunque campionato di calcio, ma ‘casa’ per questi due club è il Sudan.
All’inizio di luglio, 8 delle 24 squadre della massima serie sono tornate a giocare nel loro Paese, un Paese che dalla primavera del 2023 è intrappolato in una guerra che è costata la vita ad almeno 150 mila persone e che ha costretto 12 milioni di sudanesi a fuggire.
Un campionato in forma ridotta, che si è giocato in pochissime città, quelle considerate più sicure come Al Damir, Berber e ad Atbara, 320 km a nord di Karthoum, una città simbolo del calcio sudanese e simbolo della sua resistenza. Perché il calcio, in Sudan, è sempre stato strumento di lotta.
“Siamo finalmente tornati a casa, davanti ai nostri tifosi, con l’atmosfera del campionato”, aveva detto all’agenzia francese AFP, Mohamed Abdel Rahman, capitano e cannoniere dell’Al Hilal. La sua squadra, come le altre, non ha mai smesso di allenarsi e giocare. Insieme all’ Al Merreikh – entrambe squadre antiche e storiche nate negli anni Venti – ha continuato in Mauritania.
‘Stiamo dando il massimo per rendere felici i nostri tifosi, per regalare loro una dose di gioia in mezzo alla difficile situazione in Sudan’, aveva aggiunto.
E lo daranno, ancora, nel torneo dove si affronteranno i migliori club del continente, la Champions League africana, appunto, come sta dando il meglio la nazionale, i Falcons di Jediane, i falchi che puntano alla qualificazione ai Mondiali del 2026.
“In un momento in cui la nostra nazione sta affrontando immense sofferenze e sfollamenti, il calcio è riuscito a fare ciò che la politica non è riuscita a fare: ha messo a tacere il rumore della guerra, anche se solo per 90 minuti”, ha detto Badran Albatal, consulente della Federcalcio sudanese, a OkayAfrica.
Ma questa non è la prima volta che il calcio riesce a fare quello che non riesce a fare la politica, o forse a fare politica, quella più alta, immaginativa, che vuole cambiare un presente intollerabile.
“Il calcio in Sudan non è mai stato solo un gioco. Sotto il dominio coloniale anglo-egiziano, nacque come strumento di controllo, concepito per disciplinare e plasmare i giovani sudanesi.
Gli amministratori britannici introdussero il calcio nei programmi scolastici come parte della loro più ampia “missione civilizzatrice”, sperando di trasformare i ragazzi sudanesi in soggetti docili per il servizio coloniale”, racconta OkayAfrica.
Gli studenti, però, furono loro a trasformare i campi di calcio in “luoghi di dialogo politico e silenziosa ribellione”. E dopo il 1924, gli studenti ed i lavoratori, fecero dei club spazi di organizzazione per la resistenza anticoloniale.
Ad Atbara furono i ferrovieri, ricorda OkayAfrica, a fondare squadre di calcio che erano centri di attivismo, e sempre ad Atbara, negli anni ’40, la Workers’ Affairs Association, organizzò la sua mobilitazione proprio sui campi da calcio. “Il calcio divenne un’arena politica in cui la resistenza non solo veniva immaginata, ma anche praticata attivamente”, si legga ancora.
In Sudan, il Paese che per primo, nel 1957, ha ospitato al Coppa d’Africa e che ha fatto del calcio uno strumento di cambiamento sociale lungo tutta la sua storia, il fischio d’inizio delle partite di nuovo giocate sul terrendo di casa, una casa in fiamme e divisa, travolta dagli odi e della violenza, è stato ancora una volta un fischio di speranza e di nuovo simbolo della resistenza di un popolo, ma anche della sua unità a dispetto delle lacerazioni.
Ora, tutto il Paese sogna il Mondiale e aspetta il fischio d’inizio di una nuova stagione, che possa essere anche stagione di pace.
Potrebbe interessarti anche:
- Gaza: Bombardamenti su Deir al-Balah colpiscono zone ONU
- Afp: “I giornalisti di Gaza non ce la fanno più per la fame”
- Gaza: è “femmini-genocidio”
- Il progetto che dà voce alle donne africane over 60
E se credi in un giornalismo indipendente, serio e che racconta il mondo recandosi sul posto, puoi darci una mano cliccando su Sostienici