Giorno 1 – Ritorno a Kabul
Scritto da Barbara Schiavulli in data Giugno 11, 2021
Maryam è seduta accanto a me sul volo Dubai-Kabul. Mi chiede subito se mi dà fastidio se lascia la sua borsa sul sedile al centro tra di noi sperando che non arrivi nessuno. Ha una mascherina nera, un velo bordeaux che incornicia il viso dai caratteri orientali che caratterizzano gli afghani azara, una delle etnie più colpite in Afghanistan perché la maggior parte sono sciiti. I talebani e quelli di al-Qaida, nonché l’Isis, sono sunniti.
Ha i capelli meshati, le ciglia finte che si deve essere messa a Dubai, un abito lungo tipico, ma di buona fattura, ai piedi delle eleganti decolté con un bel tacco alto, che faticherei a portare anche da seduta. Trasuda gentilezza, mi offre metà del suo pranzo che io non ho acquistato, prova a darmi delle patatine, perfino l’igienizzante che pare sia diventata una delle maggiori forme di cortesia.
Mi racconta che è andata qualche giorno a Dubai con la figlia, la madre e la sorella. Avevano bisogno di staccare perché l’aria è diventata irrespirabile a Kabul. «Volevo che la mia bambina sapesse che ci sono posti dove si può camminare senza avere sempre paura». Penso che non sono cose che si raccontano a una sconosciuta su un aereo, ma poi penso anche che forse in quel momento sono l’unica persona a cui lei può confidare qualcosa del genere. Non ci sono molte donne sull’aereo, ma non sono neanche poche. Gli uomini faticano a tenere le mascherine, se parlano l’abbassano, se starnutiscono l’abbassano, se si grattano un ginocchio l’abbassano.
In Afghanistan ora è “allerta quattro” per il Covid, gli ospedali sono pieni, le scuole sono chiuse, eppure nessuno sembra farci troppo caso. Le hostess e gli steward del volo sono coperti dal camice usa e getta, indossano mascherine e occhiali come se fossimo in ospedale. Il che rende molto l’idea di quello che ci aspetta.
Ma d’altra parte, quella che per noi è stata un’emergenza globale per loro è solo un altro modo di morire che si aggiunge a quelli che già li travolgono ogni giorno. E un po’ li capisco se sono fatalisti, basta andare al mercato per rischiare di saltare in aria, o a scuola, basta pensare a cose semplici come guidare la macchina o voler lavorare, che per una donna già diventa una lotta per la vita.
Maryam mangia, io leggo, ogni volta che alzo lo sguardo vedo dal finestrino sterminate distese di montagne, qualche piccolo villaggio di fango e paglia che si mimetizza con il paesaggio. Passiamo sopra l’Iran, sopra Kandahar, roccaforte dei talebani, scorriamo verso Kabul che si profila con qualche casetta per poi diventare dall’alto una città vera, fatta di palazzi, strade, traffico convulso. Dall’alto sembra tutto così tranquillo, così pacifico. Basta salire di 2.000 metri e i pericoli, le paure, i problemi spariscono.
Maryam si abbassa la mascherina e si aggiusta il rossetto, si vede che viene da una famiglia bene, altrimenti probabilmente non avrebbe mai potuto lasciare le mura di casa come fanno la maggior parte degli afghani, molti dei quali non hanno lavoro, che sia la crisi o sia la guerra.
Hai paura che i talebani tornino? «Ce ne andiamo se loro tornano. Guardami: nessuno mi nasconderà sotto un burqa. Nessuno impedirà a mia figlia di studiare. Nessun paese, per quanto una possa amarlo, può chiedere un tale sacrificio».
Un paese che dopo 20 anni di faticose e piccole conquiste potrebbe cancellare di nuovo le donne come accaduto negli anni Novanta, quando i talebani erano al potere. Le avevano chiuse in casa. Relegate dietro i salwar kamize dei loro padri o mariti. Non avevano voce, ma dentro urlavano. Non potevano studiare, ma di nascosto lo facevano. Non potevano lavorare, ma sotto i burqa continuavano a sognare. E oggi sono qui, con almeno alcune che le cose le fanno, vuoi perché sono ricche, vuoi perché hanno una famiglia progressista, vuoi perché una società civile ora esiste. Qualche donna guida, qualche donna fa la politica, qualche donna è persino una influencer. Fanno arte, fanno differenza, si fanno sentire.
Arriviamo a Kabul. Atterriamo e non vedo l’ora di affacciarmi dallo sportellone, in tempi normali – per quanto possano mai esserlo a Kabul – avrei respirato l’aria di montagna, sempre un po’ troppo inquinata, a pieni polmoni, ora devo accontentarmi di farlo metaforicamente perché la mascherina copre l’odore tipico di Kabul.
Il caldo ci avvolge come un abbraccio, 2.000 metri, 31 gradi, la luce di un sole accecante. Ci muoviamo verso l’aeroporto, la prima volta c’erano ancora le macerie delle guerre precedenti, ora è tutto nuovo e moderno per quanto possa esserlo qui. Ai passaporti un poliziotto studia la mia foto, mi chiede di togliere la maschera, mi dà il benvenuto e mi lascia andare. Non ci sono molti occidentali, qualcuno di qualche ong. Qualche giornalista, gli altri sono tutti afghani pieni di valige e di scorte fatte a Dubai. Prendo un carrello, igienizzo tutto, saltello verso l’uscita a circa 500 metri.
Oltre il cancello c’è quel mondo che per molti è spaventoso e che sono tornata a raccontare. Vent’anni di viaggi, storie, emozioni. Anche con la mascherina lo riconoscerei ovunque, il mio fixer, ormai da dieci anni, sventola le braccia verso di me. Anche se non lo vedo so che sorride di gioia un po’ perché gli piace quando lavoriamo insieme, e un po’ perché i soldi che prenderà gli permetteranno di stare tranquillo per un po’ di tempo. Ha due bambini, una moglie e il desiderio di andarsene negli Stati Uniti. Carica la mia roba e andiamo subito a cercare una sim card. Facile da comprare, un po’ più complicato attivare tutto, ma nel giro di un’oretta abbiamo fatto. Hashmat sfreccia tra le strade complicate di Kabul dove più che traffico, è una giungla e lui è parte attiva del disastro, visto che per evitare di girare troppo lontano da dove vuole andare, ci facciamo almeno 500 metri contromano con le macchine che ci vengono incontro mentre lui strombazza come se fossero tutti gli altri ad andare nella direzione sbagliata.
Ridacchia perché lo rimprovero sempre. Siamo esattamente dove ci eravamo lasciati l’ultima volta. Può passare il tempo, possono succedere cose, può perfino esplodere una pandemia, ma ci sono rapporti che non cambiano mai: si basano sul rispetto e il lavoro sodo. E la consapevolezza di essere sulla stessa barca.
Gli dico di non stare troppo vicino ai mezzi militari, di non andare vicino ai minibus che sono diventati un obiettivo: due fatti esplodere nei giorni scorsi. Gli dico cose che sa, ma difendo il mio ruolo di “saggia”.
In hotel mi arrabbio subito. Controllano i bagagli e mi mettono le mani nella borsa. E il Covid? Sto a sciogliermi con l’igienizzante e poi arriva una qualunque e ficca le mani tra le mie cose. Mi lamento, dico che devono avere i guanti o la mia borsa non la tocca nessuno. Anche questo non cambia mai: per quanto ami questo posto, mi fa impazzire di rabbia molto spesso.
Viaggio da due giorni ma non sono stanca. Ho voglia di raccontare questo posto come faccio da vent’anni e non riesco a smettere. Dico ad Hashmat di tornare domani, che avremmo fatto una scaletta delle persone da intervistare, delle storie da cercare, delle cose da raccontare.
Gli americani se ne stanno andando, i talebani si stanno “allargando”, il governo afghano è travolto dagli eventi. Le donne sono paralizzate dall’incertezza di quello che succederà ma anche dalla consapevolezza che indietro non si torna. Ne va delle loro vite e delle loro storie. Gli è stato detto che potevano scriversele da sole e ora vogliono farlo. Chi le difenderà? Chi le ascolterà? Chi le aiuterà?
Domani proveremo a rispondere a qualcuna di queste domande.
Ti potrebbe interessare anche:
- Il Charlie Chaplin dell’Afghanistan
- L’Afghanistan e il Pink Shuttle
- Afghanistan Giorno 3 – La paura dentro
E se credete in un giornalismo indipendente, serio e che racconta recandosi sul posto, potete darci una mano cliccando su Sostienici
Opinioni dei Lettori
I commenti sono chiusi.


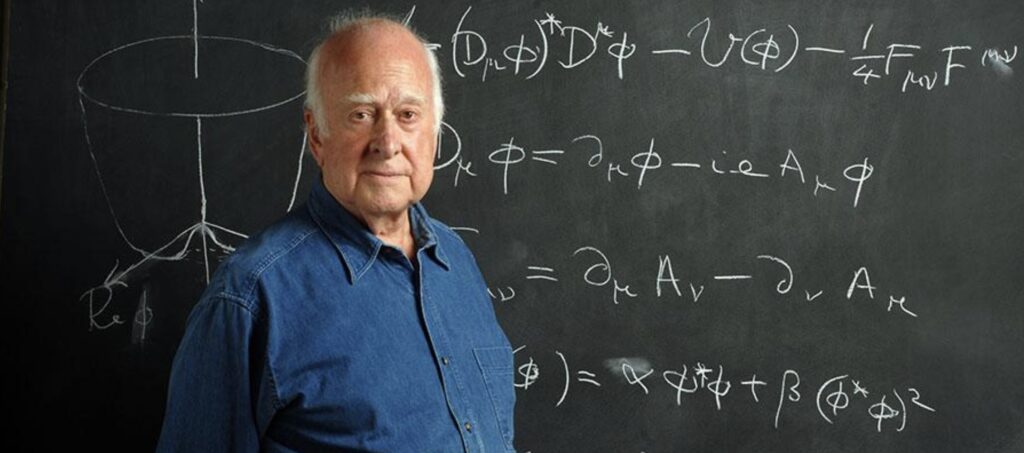



Roberto Patruno On Giugno 12, 2021 at 5:34 pm
Leggere ciò che scrive Barbara è sempre fonte della stessa emozione: si è trascinati esattamente lì dove lei si trova, con gli occhi e i sensi che non sono più i tuoi, ma quelli di lei che scrive. Ed è proprio questo che fa di lei una grande giornalista. Invidio il suo modo di scrivere. Io gioco a fare lo scrittore: romanzi, racconti, dei versi buttati giù a caso. Mi dicono che scrivo bene. A volte ho anche finito per crederci. Poi leggo le storie di Barbera e mi si ferma il respiro. Porca miseria, non mi riuscirà mai di scrivere come lei. Bravissima Barbara. Non smettere mai di farci conoscere il mondo.