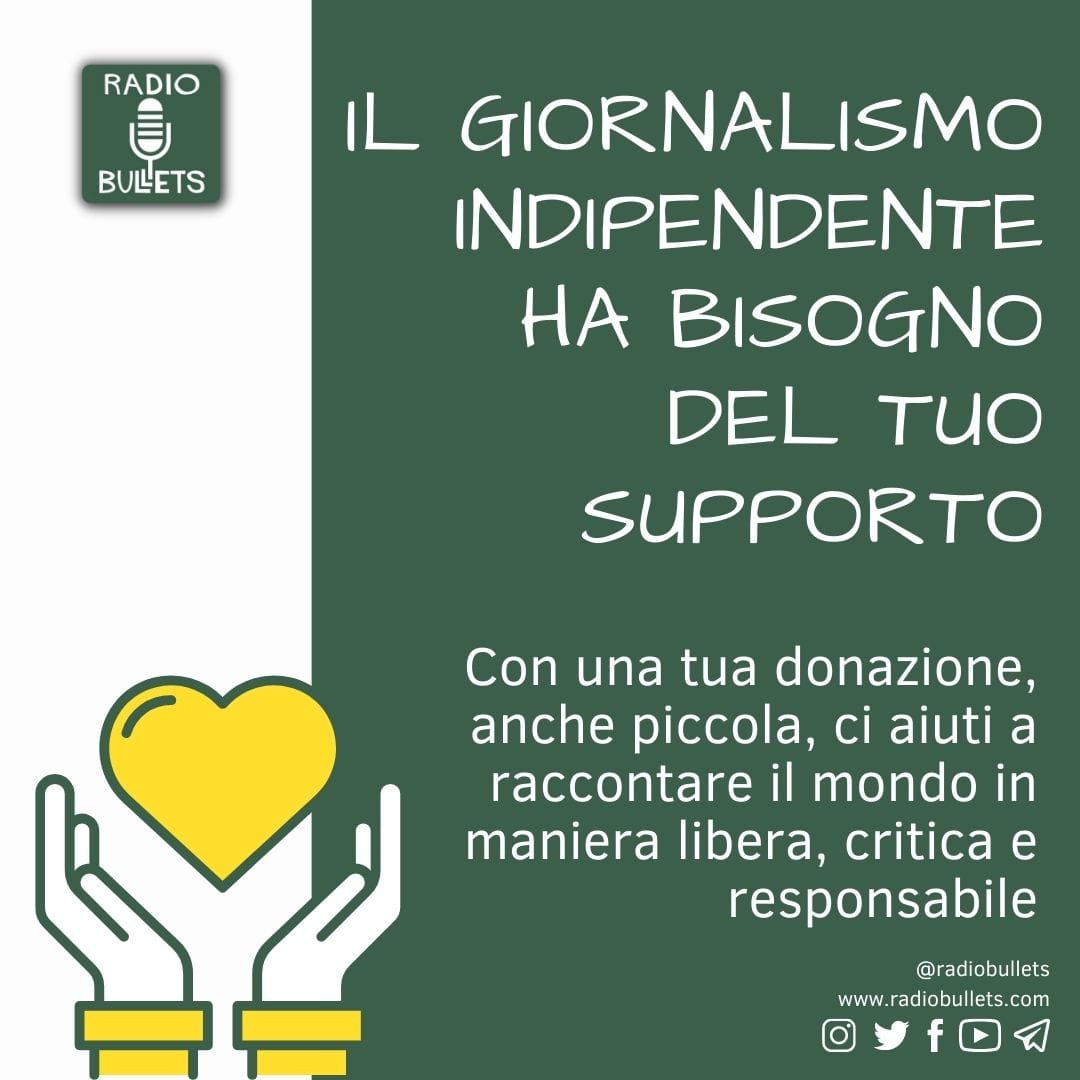10 ottobre 2025 – Notiziario Africa
Scritto da Elena Pasquini in data Ottobre 10, 2025
- Etiopia – Ombre di guerra nel Corno d’Africa
- Sud Sudan – Il cessate il fuoco è solo un ricordo
- Mozambico – Cabo Delgado in fiamme
- Nigeria – Le voci dimenticate di Boko Haram
- Somalia – Lo swahili come lingua di libertà
Questo è il notiziario Africa di Elena L. Pasquini
“La pace non si può mantenere con la forza. Può essere raggiunta solo attraverso la comprensione. Non puoi sottomettere con la forza una nazione se non stermini ogni uomo, donna e bambino. A meno che tu non intenda ricorrere a misure tanto drastiche, devi trovare un modo per risolvere le tue controversie senza ricorrere alle armi”, sosteneva Alfred Einstein.
Le parole di Einstein risuonano nel nostro mondo che continua a sceglie sempre la strada delle armi, in Africa come in Europa, in Medio Oriente, e altrove. Un monito per l’Etiopia e l’Eritrea perché scelgano il dialogo e non tronino alle armi.
Ed dai venti di guerra in Corno d’Africa che partiamo, per andare poi in Mozambico e in Sud Sudan, dove a prevalere è ancora la violenza armata. Quindi, ascolteremo le voci delle vittime di Boko Haram in Nigeria, per chiudere con l’idea antica di unità africana che passa attraverso una lingua comune, lo swahili, e che viene da un Paese senza pace, la Somalia.
Etiopia
Non cessa di agitarsi lo spettro della guerra nel Corno d’Africa, nel mutare continuo di alleanza, amicizie, nel riapristi di vecchie fratture e nel generarsi di nuove.
L’Etiopia accusa l’Eritrea di esser pronta all’offensiva militare, e di farlo insieme al TPLF, il Fronte di Liberazione popolare del Tigray, la regione del nord con cui il governo di Addis Abeba ha combattuto, tra il 2020 e il 2022, una guerra tra le più drammatiche nella storia recente, e un partito, il TPLF che ha dominato la politica del Paese fino all’ascesa del presidente Amy Ahmed nel 2018.
Timori avanzati da Gedion Timothewos, il ministro degli esteri che avrebbe inviato una lettera la al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, come ha riportato la stampa locale e l’agenzia francese AFP.
“La collusione tra il governo eritreo e il TPLF è diventata sempre più evidente negli ultimi mesi”, scrive Timothewos. “L’ala più intransigente del TPLF e il governo eritreo si stanno attivamente preparando a fare guerra contro l’Etiopia.”
L’Etiopia accusa l’Eritrea di finanziare, mobilitare e armare gruppi armati anche nella regione Amhara, dove da anni il governo federale combatte contro milizie ribelli. L’Eritrea, a sua volta, accusa Addis Abeba di avere ambizioni sul porto di Assab per garantirsi un accesso al mare.
“Il messaggio riflette il rapido deterioramento delle relazioni tra Etiopia ed Eritrea, due paesi confinanti che condividono una storia di conflitti sanguinosi lunga decenni. Dopo l’indipendenza dell’Eritrea nel 1993, i due paesi del Corno d’Africa entrarono in guerra tra il 1998 e il 2000, un conflitto che causò decine di migliaia di morti.
I rapporti si distesero nel 2018, quando il primo ministro etiope Abiy Ahmed salì al potere. Durante la guerra del Tigray (2020–2022), l’esercito eritreo appoggiò le forze federali etiopi contro il TPLF”, ricorda Al Jazeera.
Sud Sudan
Il cessate il fuoco non tiene, il Sud Sudan rischia di precipitare in una guerra che potrebbe tragicamente assomigliare a quella che si combatte nel Sudan, il Paese da cui si è staccato nel 2011 senza però trovare mai veramente pace. L’accordo di pace che ha messo fine, nel 2018, alla guerra civile scoppiata poco dopo l’indipendenza, è soggetto a segnalato “ripetute e costanti violazioni”, secondo diplomatici britannici e norvegesi, come racconta Suda War Monitor.
La situazione, in questo Paese poverissimo, lacerato dalle divisioni politiche e che è diventato luogo di rifugio per chi scappa dalla guerra di Karthoum, è precipitato dopo l’arresto di uno dei vicepresidenti, Riek Machar, capo dell’opposizione, da parte del presidente Salva Kiir.
“L’arresto e la rimozione di Machar dall’incarico miravano a facilitare la successione del secondo vicepresidente Benjamin Bol, protetto di Kiir, socio in affari di lunga data e suo legittimo erede”, scrive Sudan War Monitor, ricordano che Machar è uno dei principali firmatari dell’accordo di pace.
“Se le attuali sfide non vengono affrontate con urgenza, vi è un alto rischio di inversione dei progressi già conseguiti e potrebbe portare al collasso totale dell’accordo”, ha avvertito George Aggrey Owinow, diplomatico keniota ed ex generale a capo dell’RJMC, l’organismo di monitoraggio internazionale del cessate il fuoco, che si è riunito questa settimana a Juba. David Ashley, ambasciatore britannico, ha spiegato come i progressi compiuti in passato siano stati tutti annullati.
“Il licenziamento unilaterale, o persino la detenzione, di oppositori politici senza consultare i partner dell’Accordo compromette la pace e rischia di provocare ulteriori conflitti”, ha detto. “Il cessate il fuoco permanente a livello nazionale, a cui tutte le parti si erano impegnate, non è più valido.
Entrambi i partiti più grandi, SPLM-IG e SPLM-IO, sono impegnati in scontri armati regolari in almeno quattro stati e si definiscono pubblicamente nemici. Questo è già costato migliaia di vite e ha causato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone ..
“Questo deve finire subito, se vogliamo evitare una nuova guerra nel Sudan del Sud”, ha aggiunto.
Secondo il Sudan War Monitor, “l’attuale ritorno alla guerra nel Sudan del Sud fa parte di un arco sempre più ampio di instabilità, guerra e disastri umanitari nell’Africa orientale, che si estende dai campi profughi del Ciad orientale alle città del Darfur, alle pianure del Kordofan, ai Monti Nuba, lungo il confine tentacolare tra i due Sudan, attraverso le zone umide della regione dell’Alto Nilo e nelle profondità delle foreste dell’Equatore, fino al confine con l’Uganda”.
Mozambico
Nel Nord del Mozambico, a Cabo Delgado, a otto anni dall’inizio della guerra, i combattimenti sono ripresi, sempre più intensi. Solo nell’ultima settimana sono circa 22 mila le persone sfollate, secondo i dati dell’UNHCR, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati.
Nel 2025, sono state 100 mila le persone costrette ad abbandonare la propria casa, 1,3 mila in tutto, e in molti hanno dovuto lasciare tutto più di una volta, in questo conflitto dove alle violenze perpetrate dal gruppo armato al-Shabaab, si sono aggiunti gli effetti devastanti di cicloni, inondazioni e siccità.
“Le famiglie stanno raggiungendo il limite”, ha affermato Xavier Creach, rappresentante dell’Agenzia in Mozambico.
Omicidi, rapimenti, violenze sessuali, reclutamento forzato dei bambini, sono i civili ad essere presi di mira, spiegano dall’UNHCR. “Donne e ragazze sono particolarmente vulnerabili quando vanno a raccogliere acqua o legna da ardere, e le persone con disabilità o anziane spesso non riescono a sfuggire alla violenza. Molte sono traumatizzate e hanno urgente bisogno di supporto psicosociale, ha aggiunto Créach”.
Secondo l’Agenzia per i rifugiati, “la nuova ondata di sfollamenti in Mozambico è una delle più grandi registrate negli ultimi otto anni. Il sistema sanitario sotto assedio”. L’Organizzazione mondiale della Sanità, stima che “circa il 60 per cento delle strutture nei distretti più colpiti non sono operative a causa dell’insicurezza, dei saccheggi e dello sfollamento del personale”.
Nigeria
Donne, soldati, contadini, pescatori. Sono le voci di quarantasette persone, vittime del conflitto di Boko Haram. Raccontano se stesse senza mediazione in un libro, The World Was in Our Hands, Il mondo era nelle nostre mani, curato da Chitra Nagarajan, che le ha raccolte tra il 2016 e il 2021.
“Tante storie di sofferenza in Africa sono raccontate da altri; così poche da chi le vive”, si legge in un articolo pubblicato da The Continent e dalla Harare Books Review. “Un racconto orale di chi ha vissuto il conflitto di Boko Haram vuole porre rimedio”.
Le vittime si raccontano nella loro lingua e hanno il controllo della loro storia, la revisionano.
Tante le testimonianze di donne e ragazze, delle “mogli” di Boko Haram, donne rapite contro la loro volontà, ma anche donne che hanno scelto di seguire il gruppo di matrice islamista nato in Nigeria agli inizi degli anni Duemila. “[E]ra bello avere questo potere dopo una vita in cui ti dicevano che non ne avevi nessuno perché eri una ragazza. Noi mogli potevamo fare tutto ciò che volevamo, qualunque cosa fosse”, racconta qualcuna.
Altre invece, raccontano di fughe, di figli strappati alle madri, di uomini nascosti a rischio della vita. C’è la storia di una madre che ha seppellito suo figlia sottoterra per proteggerla dal rapimento, c’è la voce di quella ragazza.
Un libro che è “un’importante e rara testimonianza del conflitto di Boko Haram raccontata da coloro che lo hanno vissuto e lo vivono ancora”, scrivono le due testate africane.
Somalia
Nelle scuole e nelle università della Somalia si insegnerà la lingua swahili, insieme alle lingue ufficiali, il somalo e l’arabo, e all’inglese. Lo ha annunciato il presidente Hassan Sheikh Mohamud, durante un incontro della Comunità dell’Africa Orientale, di cui la Somalia è entrata a far parte lo scorso anno.
L’obiettivo è rafforzare i legami con i paesi del blocco che lo utilizzano, così come era stato con l’arabo che divenne e lingua curriculare quando Mogadiscio si unì alla Lega Araba nel 1974.
“Lo swahili è importante per la nostra integrazione nella regione”, ha detto Mohamud.
“Vogliamo che lo swahili diventi una lingua di comunicazione, commercio e apprendimento — e che possa persino sostituire l’inglese durante la nostra prossima conferenza”, ha aggiunto il ministro dell’Istruzione, Farah Sheikh Abdulkadi.
Una lingua che però è già diffusa in Somalia, in particolare lungo la costa meridionale, “una delle conseguenze della guerra civile esplosa nel 1991, che ha portato decenni di instabilità e, più recentemente, di violenza jihadista. Centinaia di migliaia di persone hanno cercato rifugio oltre il confine, in Kenya, dove molti hanno imparato a parlare lo swahili — soprattutto coloro che hanno frequentato il sistema scolastico keniota.
Poiché la situazione in Somalia si è in parte stabilizzata negli ultimi anni, alcuni di questi parlanti fluenti di swahili sono tornati o mantengono legami con il proprio paese d’origine; anche la presenza delle truppe dell’Unione Africana ha contribuito alla diffusione della lingua”, scrive la BBC.
Lo swahili è una delle lingue più diffuse dell’Africa, dove è la lingua di un terzo del continente e di circa 200 milioni di parlanti, la maggior parte dei quali non nativi.
“Un tempo era un oscuro dialetto insulare di una lingua bantu … Nel corso dei due millenni di crescita e adattamento dello swahili, i protagonisti di questa storia — immigrati dall’interno dell’Africa, mercanti asiatici, occupanti arabi ed europei, coloni europei e indiani, amministratori coloniali e cittadini di vari stati postcoloniali — hanno usato e adattato lo swahili ai propri scopi, portandolo con sé ovunque siano andati verso occidente”, scrive John Mugane, professore all’Universtà di Harvard in un contributo su The Conversation che ne ripercorre la storia.
“Le terre storiche degli Swahili si trovano lungo il litorale dell’Oceano Indiano dell’Africa orientale, una catena di città costiere lunga 2.500 chilometri che va da Mogadiscio (Somalia) a Sofala (Mozambico), comprendendo anche isole al largo come le Comore e le Seychelles”.
Questa regione costiera è stata per secoli un crocevia internazionale di commerci e di movimenti umani”, scrive Mugane. “Chiunque arrivasse sul litorale dell’Africa orientale poteva scegliere di diventare Swahili — e molti lo fecero”.
Una lingua che divenne lingua amata e sostenuta da intellettuali, attivisti, artisti; che divenne simbolo di unità africana e lingua di liberazione. “Per molti africani, l’ascesa dello swahili segnò una vera indipendenza culturale dalle lingue coloniali europee. La Tanzania fu l’unico paese africano, insieme all’Etiopia, a usare una lingua nativa (lo swahili) come lingua ufficiale dello Stato e dell’istruzione di base.
Il termine swahili uhuru (“libertà”) divenne un simbolo universale di emancipazione politica”, aggiunge ancora Mugane, che conclude: “La chiave per comprendere questa storia è osservare come il popolo Swahili abbia saputo adattarsi, innovare e resistere, mantenendo equilibrio tra confronto e cooperazione nel contatto con altre culture e lingue”.
GSF, Schiavulli: “Occhi su Gaza. Non siamo complici. Lo è la politica” – Il podcast
Potrebbe interessarti anche:
- GSF, rientro di 26 connazionali
- GSF: No, questa non è una crociera
- GSF: Fermi, ma non immobili
- Gaza, GSF: “Corridoi umanitari via terra”
- Israele, terminata visita consolare a fermati Flotilla
- GSF: le prime reazioni al rientro a casa e i prossimi piani
E se credi in un giornalismo indipendente, serio e che racconta il mondo recandosi sul posto, puoi darci una mano cliccando su Sostienici