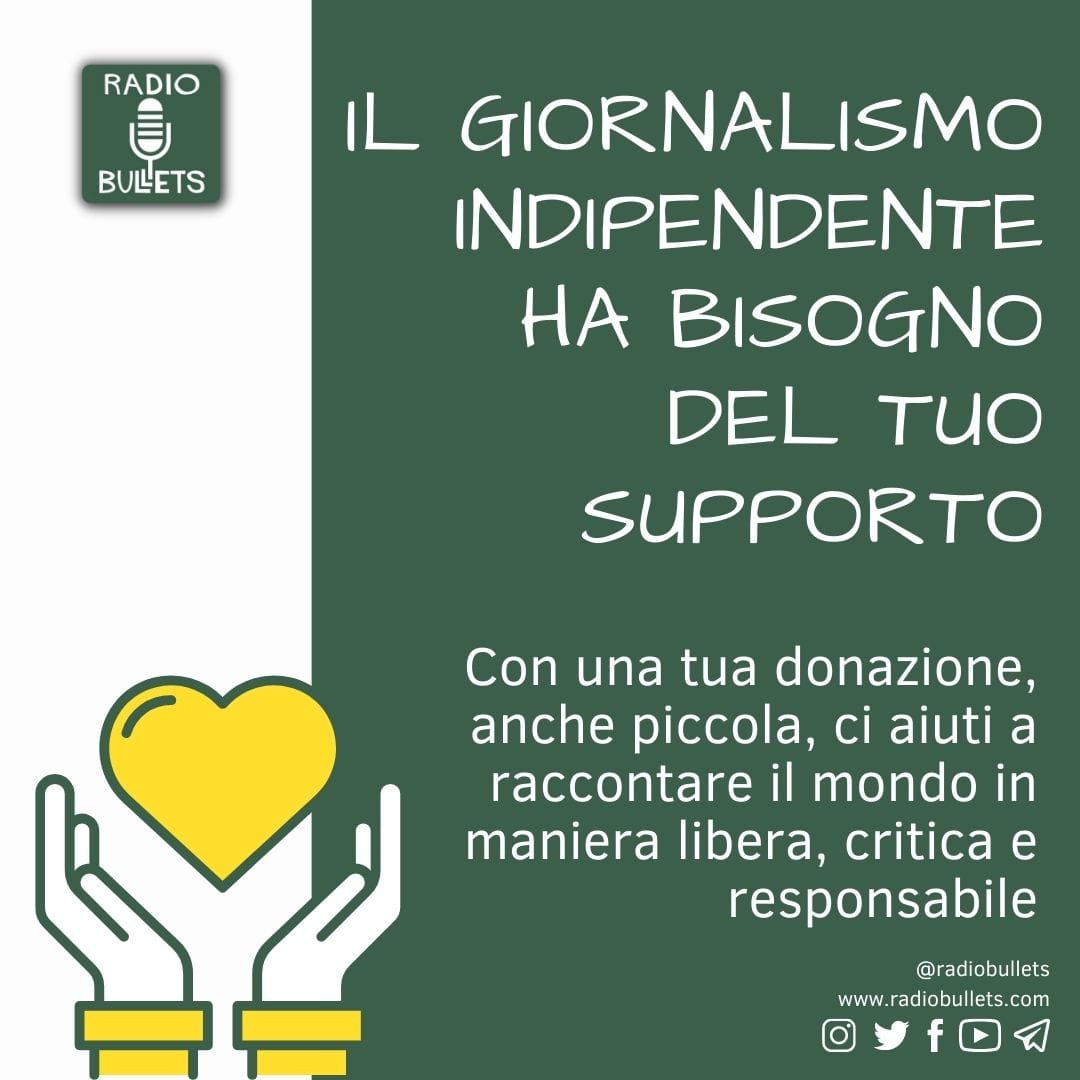14 agosto 2025 – Notiziario Africa
Scritto da Elena Pasquini in data Agosto 14, 2025
- Sudan, ancora un attacco ad un campo profughi, mentre dove si muore di fame ed è “emergenza di genere”.
- Gambia, neonata muore dopo mutilazione genitale.
- Etiopia, attiviste femministe perseguitate e costrette all’esilio.
- Nigeria, una sacerdotessa Yoruba sfida discriminazioni e pregiudizi religiosi.
Questo e molto altro nel notiziario Africa a cura di Elena L. Pasquini
“Se potessi rivolgermi alle ragazze e alle donne di tutto il mondo, farei loro questo semplice invito: sorelle mie, figlie mie, amiche mie, trovate la vostra voce! …. Abbiamo bisogno che le nostre voci vengano ascoltate. Trovate la vostra voce! E alzate la voce! Che la vostra sia una voce per la libertà!”.
Era questo l’invito e il grido Ellen Johnson Sirleaf, quando nel 2011 accettava il Premio Nobel per la Pace, lei, la prima donna ad essere eletta Capo di stato in Africa.
È con le sue parole in mente che oggi andremo in Sudan, dove le donne pagano con il “sangue, le lacrime e la dignità”- per rubare di nuovo le parole a quel discorso ancora tragicamente attuale – il prezzo della guerra scoppiata nel 2023.
E andremo in Gambia, dove una neonata di un mese è morta dopo una mutilazione genitale, in Etiopia dove le attiviste femministe sono sotto attacco, in Nigeria per raccontarvi la storia di una sacerdotessa che difende il suo credo. E poi, nella scena artistica africana, tra marginalità e successi. Oggi, 14 agosto, 2025.
Sudan
Non c’è un luogo sicuro in Sudan, non c’è un luogo dove sfuggire alla guerra. Non basta abbandonare le proprie case. Lunedì sono morte almeno 40 persone in un attacco nel campo profughi di Abu Shouk, in Darfur, vicino alla città sotto assedio di El-Fasher, la città ultimo baluardo dell’esercito nella regione in mano alle Forze di Supporto Rapido.
Secondo la stampa locale, il campo si sarebbe trovato in mezzo al fuoco incrociato; in mezzo, tra l’esercito e i paramilitari, un tempo alleati, che si combattono dal 2023.
Ma il gruppo umanitario di Abu Shouk, dove vivono almeno 200.000 persone, racconta di “vittime uccise a colpi d’arma da fuoco nelle loro case, mentre altre sarebbero state uccise a colpi d’arma da fuoco in pubblico”, come riporta la BBC.
A colpire, prendendo di mira i civili, sarebbero state le RSF, il gruppo armato che ha le sue radici nelle milizie Janjaweed accusate di aver commesso il genocidio del Darfur nell’altra guerra scoppiata nel 2003.
Un mese fa, un altro campo profughi era stato attaccato, quello di Zamzam in questo conflitto armato che ha causato 12 milioni di sfollati e oltre 150 mila morti, e dove sono le donne a pagare il prezzo più altro.
C’è fame nei campi che sono sempre possibili bersagli, dove chi può si nutre di mangimi per animali, dove è difficile che arrivino gli aiuti e dove c’è quella che le Nazioni Unite definisce una “emergenza di genere”, come ha dichiarato a UN News Salvator Nkurunziza, ncurunziza rappresentante di UN Women in Sudan.
Martedì, durante una conferenza stampa, l’agenzia dell’ONU ha definito donne e ragazze “i volti più affamati di questa crisi”, sottolineato l’impatto sproporzionato che la crisi alimentare ha avuto su donne e ragazze.
Donne, ragazze, particolarmente vulnerabili proprio quando chiedono aiuto: “Le donne e le ragazze sfollate possono essere soggette al rischio di sfruttamento e abusi, soprattutto durante la distribuzione degli aiuti, dove in alcune località i meccanismi di protezione sono deboli o assenti”, ha affermato Nkurunziza.
Secondo l’Unità per la lotta alla violenza contro le donne in Sudan dell’agenzia sono stati registrati 1.138 casi di stupro da aprile 2023 – al marzo 2025 -, tra cui 193 minori, la maggior parte dei quali in zone colpite dal conflitto.
“Il numero effettivo potrebbe essere più alto perché la paura dello stigma e altri motivi sociali e di sicurezza impediscono una segnalazione accurata dei crimini di violenza di genere”, ha avvertito, però, Nkurunziza.
Gambia
Era una neonata, aveva solo un mese. È arrivata morta nell’ospedale della capitale del Gambia, Banjul. Morta per una emorragia. Due donne sarebbero state arrestate per aver eseguito sul suo piccolo corpo la mutilazione genitale, una pratica che comporta la rimozione parziale o completa del clitoride e delle piccole labbra.
Una pratica vietata in Gambia dal 2015 dove però ancora il 73 percento delle donne tra i 15 e il 49 anni vi è stato sottoposto. Nonostante la legge, e le pene che vanno dai tre anni all’ergastolo in caso di morte della ragazza, nel decimo paese al mondo per mutilazioni genitali, si sono verificati nel 2023 solo due processi e una condanna, come ricorda la BBC.
La morte della bambina ha scatenato un’ondata di indignazione. “La cultura non è una scusa, la tradizione non è uno scudo, questa è violenza, pura e semplice”, si legge in una nota della ONG Women In Leadership and Liberation. In un post su X, la sua fondatrice e attivista per i diritti delle donne, Fatou Baldeh ha definito le mutilazioni genitali femminili “un atto brutale e insensato”.
Le mutilazioni genitali femminili non sono cultura, sono crudeltà”, ha detto.
Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, sono oltre 230 milioni le donne e le ragazze che in tutto il mondo hanno subito mutilazioni genitali femminili. La maggior parte in Africa, circa 144 milioni, dove ci sono ancora Paesi che considerano la pratica legale e dove solo in una manciata esistono leggi specifiche che la vietano.
È la Somalia ad essere in testa all’orribile classifica dei Paesi dove si pratica con più frequenza quella che viene definita “circoncisione femminile”, inflitta alle donne per credenze che vogliono il controllo della sessualità femminile, la preservazione della verginità, la purezza, il piacere degli uomini.
E che condanna invece le donne, pena l’esclusione sociale, ad inudite sofferenze e che le priva della pienezza di quel piacere. In Somalia, il 99 percento delle donne ne è stata vittima, mentre 4 sopravvissute su 10, vivono in Paesi in guerra, in particolare in Etiopia, Nigeria e Sudan.
“La pratica delle mutilazioni genitali femminili è in declino, ma non abbastanza velocemente”, secondo il rapporto. “Stiamo anche assistendo a una preoccupante tendenza: sempre più ragazze vengono sottoposte a questa pratica in età più precoce, molte prima del quinto compleanno. Questo riduce ulteriormente la finestra temporale per intervenire”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttore Esecutivo dell’UNICEF, come riporta AfricaNews.
Etiopia
La rete è piena dei suoi video intimi, di messaggi e poi, insulti, offese. Lei è Jordin “Jordi” Bezabih ed è un’attivista femminista, una delle più note e seguite in Etiopia. I suoi account sono stati hackerati, la sua vita travolta fino a costringerla a lasciare il suo Paese.
Su uno soltanto dei canali che abbiamo visto sono migliaia gli iscritti, ma la rete è piena di contenuti che attaccano Jordin con un’accusa ben precisa: promuovere le relazioni omosessuali.
E Jordin, una delle co-fondatrici del gruppo di pressione Setaset Power, che in amarico si traduce “donne al potere”, è solo l’ultima tra le attiviste etiopi che ricevono minacce, ogni giorno di più. Un’altra femminista, Lella “Emama Fishka” Misikir, ha lasciato l’Etiopia dopo aver ricevuto una valanga di minacce di morte”, scrive Samuel Getachew su The Continental.
“Le persone che le molestano tendono a collegare il femminismo alla “promozione” delle relazioni tra persone dello stesso sesso e affermano di agire contro la cultura e la tradizione religiosa dell’Etiopia.
Questa narrazione gioca un ruolo fondamentale in una delle società più conservatrici dell’Africa. In un Paese in cui le relazioni omosessuali sono criminalizzate e punibili con pene detentive fino a 15 anni, essere accusati di omosessualità può essere devastante.
Costringe molte persone ad abbandonare l’attivismo o a fuggire”, spiega Getachew, che racconta di come gli attivisti ritengano che dietro le molestie a Jordin ci siano attori legati allo Stato, complici o che semplicemente si sono voltati dall’altra parte. “Prima che i suoi messaggi privati venissero divulgati, la polizia ha arrestato Jordin e le ha confiscato il telefono”, si legge ancora.
Mentre si alza sempre più forte la voce di chi chiede libertà e diritti, le campagne contro le attiviste e la caccia agli omosessuali si fanno sempre più intensi. A novembre del 2024, un’indagine dell’agenzia di stampa francese Agence France Press insieme a Deutsche Welle Akademie aveva rivelato la crescente brutalità degli attacchi online alle femministe.
Dall’analisi di oltre 300 post pubblicati su TikTok e Facebook, e dalle chat in diretta sui social media, è emerso un quadro di sconcertante violenza contro le donne che difendono i loro i diritti e quelli LGBTQ+.
“Gli insulti spaziavano da commenti denigratori sul loro aspetto fisico a vere e proprie minacce di violenza fisica. “Se incontro questa donna faccia a faccia, prometto che le sparo in testa”, si legge in uno dei tanti commenti denigratori sotto un video pubblicato sull’account TikTok di uno degli attivisti”, scrive AFP, che spiega come gli attacchi online che prendono di mira attiviste femministe e giornaliste spesso contengono riferimenti alla loro sessualità e le etichettano come “lesbiche”.
Joridn Bezabih, come altre attiviste, era già stata oggetto di violenza, quando aveva lanciato una grande campagna online #JusticeforHeaven dopo lo stupro e omicidio di una bambina di sette anni, Heaven Awot, nell’agosto del 2024.
“Jordin e altre attiviste sono diventate bersaglio di attacchi feroci che vanno da false affermazioni legate alla loro sessualità a insulti misogini e minacce fisiche”, riportava AFP, a cui Jordin aveva raccontato di essere stata costretta a cambiare casa dopo aver ricevuto una serie di minacce di morte.
Sorte simile, quella di Betelehem Akalework, accusata anche lei di promuovere l’omosessualità. “Ho ricevuto minacce di aggressioni con l’acido e di morte a causa dell’etichettatura”, ha affermato la trentaduenne madre di due figli. “Un anno fa, quando ero incinta, sono stata aggredita fisicamente e umiliata da tre uomini.”
Vittima di revenge porn, costretta a cambiare casa, anche la sua vita è stata stravolta come quella di molte altre.
Nigeria
Oreoluwa Adedoyin ha due vite. Nella sua vita pubblica è una regista, in privato una sacerdotessa Orisha. Ma Adedoyin non vuole più nascondersi, come non lo vogliono più i fedeli dei culti tradizionali nigeriani che sui social network sfidano la narrazione che li vuole adepti del demonio. Adedoyin è devota ad Esu, divinità Yoruba.
Esu, Satana per le religioni abramitiche. Lei, una strega. “In Nigeria, dove i tradizionalisti sono spesso accolti con disprezzo e ostilità, praticare la propria fede significa muoversi su un sottile confine tra segretezza ed espressione di sé”, scrive Victor Eyke, che racconta la storia di Adedoyin sulle pagine di Miniority Africa.
A febbraio di quest’anno, in un attacco nello stato di Osun durante una festa, la festa di Obatala, una delle divinità principali della religione Yoruba, sei fedeli sono stati feriti.
“In questa parte del mondo, i tradizionalisti sono visti come feticisti e demoniaci. La gente non vuole associarsi a noi”, dice Adedoyin a Eyke. “Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta se sarei riuscita ad andare avanti. Ma … non permetterò che l’opinione di nessuno scuota la mia fede”.
Adedoyin ha perso l’amore, ha rischiato di perdere la casa, ha ricevuto molte minacce, a lungo ha preferito restare in silenzio anche sul posto di lavoro. “In questo Paese, cristiani e musulmani possono pregare apertamente. Ma nel momento in cui tiro fuori il rosario, la gente reagisce come se stessi evocando i demoni”.
È stato l’Occidente, il colonialismo, nel suo incontro con i culti tradizionali a fare di Esu l’incarnazione del male, invece del ponte tra il divino e l’umano, forza benevola e protettrice.
A gennaio, attivisti Yoruba si sono mobilitati contro la discriminazione religiosa, sono scesi in piazza Lagos, a Osgbo, ma anche in molte parti del mondo: ‘Esu non è Satana’ si leggeva sui cartelli.
#EsuIsNotSatan è l’hashtag con cui hanno fatto sentire la propria voce sui social. Quelle piattaforme che usa anche Adedoyin, nonostante i messaggi di odio. “Questa è la mia strada”, ha dichiarato a Minority Africa, “e la percorrerò con orgoglio”.
Una lunga strada, quella verso la libertà di culto nella Nigeria dove in nome della religione si muore e si combatte, anche se qualche timido passo sembra sia stato compiuto.
Lo scorso inverno, Ademola Adeleke, gvernatore dello Stato di Osun, ha proposto la Settimana del Patrimonio Culturale Yoruba e ha incontrato la Traditional Religious Worshipers, l’associazione dei fedeli tradizionali, promettendo di portare avanti iniziative volte a promuovere il patrimonio culturale Yoruba, e la “coesistenza pacifica, la tranquillità e l’armonia” tra tutti le religioni dello Stato.
Arte
Tems è nigeriana, ha vinto due Grammy e ora fa sentire la sua voce oltre la musica, oltre il suo canto.
Temilade Openiyi, regina dell’afropop, in un’intervista alla BBC ha affermato che alle donne non è ancora riconosciuto rispetto nell’industria musicale.
E ha raccontato dei suoi inizi, della fatica ad esser presa sul serio: “Ho capito che c’è sempre un costo. C’è sempre un prezzo da pagare. E molti di quei prezzi non ero disposta a pagarli e non c’erano molte opzioni”, ha detto.
Tems ha lanciato una nuova piattaforma, si chiama The Leading Vibe Initiative ed è destinata a creare opportunità per le donne nell’industria musicale africana, a cambiare “il modo in cui le donne vedono se stesse”.
“Mi sono promessa che se fossi arrivata al punto di poter fare di più, avrei reso questa iniziativa accessibile anche alle donne come me e forse avrei reso più facile per le donne accedere alle piattaforme e raggiungere un pubblico più vasto e avere successo”, ha affermato.
The Leading Vibes è stata lanciata nella città natale di Tems, Lagos, dove si sono riunti “cantanti, cantautori e produttori”.
Se nell’industria discografica, le donne sono ancora ai margini di un mondo che si declina quasi solo al maschile, è nell’arte contemporanea che si sta compiendo una vera rivoluzione.
Nel 2024 sono state tutte artiste donne ad aggiudicarsi le cinque vendite più costose nell’arte africana. Avevano già superato le vendite degli uomini nel 2023, e sono rimaste in testa anche l’anno successivo.
“Questo cambiamento segna un momento significativo nella storia del mercato dell’arte, soprattutto perché le vendite globali delle artiste non hanno ancora raggiunto la parità con quelle degli uomini”, ha detto Lindsay Dewar, direttore operativo della società di ricerca ArtTactic, al britannico The Guardina, alcuni mesi fa.
“La scena artistica africana si distingue come leader, dove le artiste prosperano e ottengono risultati eccezionali”, ha aggiunto.
In testa alla classifica, Julie Mehretu, etiope-americana: il suo dipinto Mumbaphilia è stato venduto dalla casa d’aste Christie’s per 5,8 milioni di dollari.
“Le artiste nere del continente si trovano ancora ad affrontare sfide particolari, tra cui infrastrutture e rappresentanza limitate in gallerie e istituzioni, difficoltà di accesso ai mercati internazionali e pregiudizi sistemici che storicamente hanno sottovalutato il loro lavoro”, ha detto a The Guardian, Dana Endundo Ferreira, fondatrice di Pavillon 54, una piattaforma d’arte digitale.
“Molte spesso operano ancora in spazi a predominanza maschile, dove il riconoscimento arriva più lentamente”, ha aggiunto. Eppure, finalmente stanno iniziando a ricevere il riconoscimento che meritano. E stanno cambiano il mondo dell’arte contemporanea globale.
Potrebbe interessarti anche:
- Gaza: Bombardamenti su Deir al-Balah colpiscono zone ONU
- Afp: “I giornalisti di Gaza non ce la fanno più per la fame”
- Gaza: è “femmini-genocidio”
- Afghanistan: Donne rimpatriate e cancellate
- Sudan: il fragile sistema agricolo conta sul lavoro delle donne
- Repubblica democratica del Congo: ennesima strage per mano delle ADF, gruppo armato islamista
- Costa d’Avorio: proteste in vista delle elezioni presidenziali, arrestato giovane tiktoker
E se credi in un giornalismo indipendente, serio e che racconta il mondo recandosi sul posto, puoi darci una mano cliccando su Sostienici