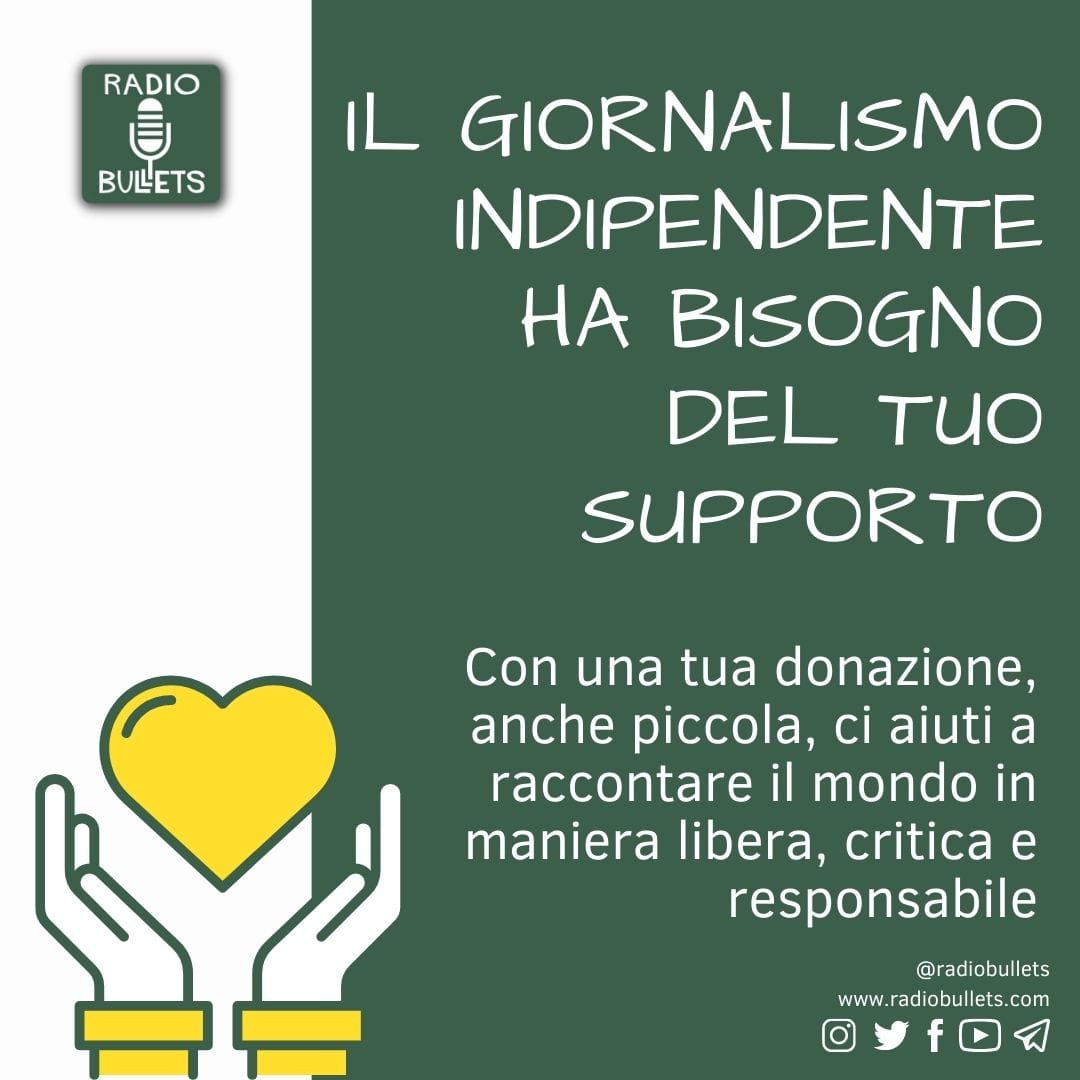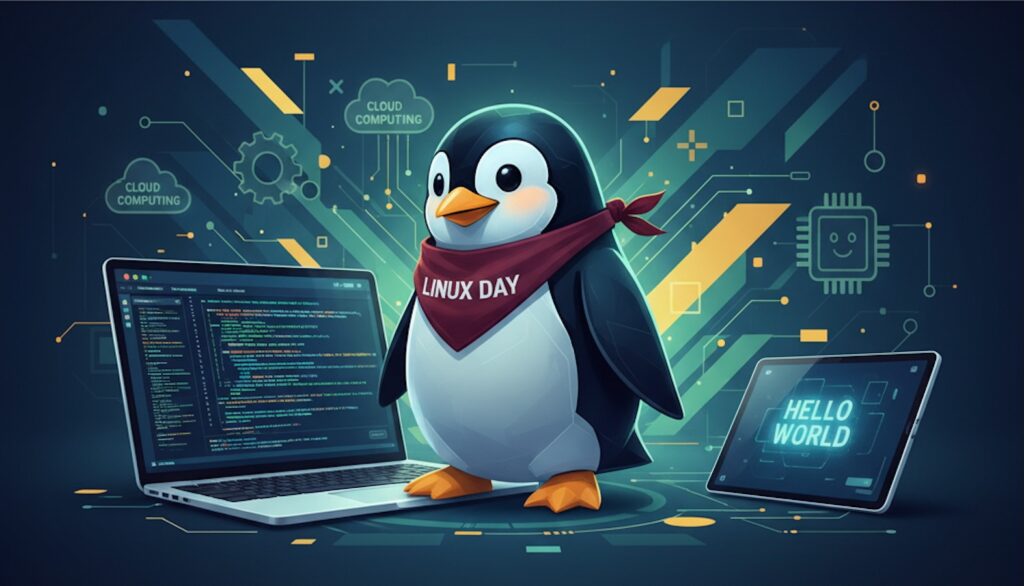Global Sumud Flotilla: La flotta – Ep.2
Scritto da Barbara Schiavulli in data Novembre 11, 2025
MAR MEDITERRANEO – “Ciao Flotilla, spero che stiate bene e tutte le vostre famiglie stiano bene, e i nostri compagni stiano bene. Siamo arrivati al momento più importante di questa missione in cui avete messo tutto il cuore e la vostra energia. È stato un onore imparare da voi. Ci stiamo muovendo verso quello che sembra un blocco militare, tra 7 e 20 miglia da qui.
Spero che riusciremo a rompere l’assedio e, se ci riusciremo, domattina saremo a Gaza. Per favore, prendetevi cura di tutti, ricordatevi l’addestramento: siamo una missione non violenta di solidarietà con i palestinesi. Ne abbiamo parlato per mesi ed è quello che resteremo. Dovremmo essere tutti contenti di quello che abbiamo fatto.
Ora abbiamo l’ultima occasione: se bloccano una nave le altre continuano e cerchiamo di arrivare a Gaza. E se dovessero arrestarci sappiamo tutti come comportarci e mantenere la dignità in uno stato coloniale. Siamo qui per solidarietà con il popolo palestinese”.
Quella voce, spezzata dal sale e dalla distanza, ci ha attraversati come un giuramento: un patto di nonviolenza, lucidità e ostinazione. Ci ha messi in riga più di qualunque ordine, ci ha cucito addosso la parola “dignità” come uno stemma.
Questo è l’ultimo messaggio, che io sappia, che manda Thiago Avila, o re Thiago come lo chiamo io, alla flotilla prima di essere abbordata in acque internazionali dalle forze speciali dell’esercito israeliano.
Qualche ora prima, i militari israeliani si erano insinuati nella radio attraverso la quale le barche della Global Sumud Flotilla comunicavano tra loro, chiedendoci di fermarci e tornare indietro.
Quella voce estranea entrata nelle nostre frequenze è stata la prima mano sul nostro timone: non una richiesta, un avvertimento. Eppure, il ponte ha trattenuto il respiro e ha scelto di non cedere.
Nessuno ha preso in considerazione l’idea neanche per un secondo. Eravamo arrivati fin lì con una missione ben precisa e solo la forza ci avrebbe impedito di andare avanti.
Non è che non ci fossero stati dubbi o domande se non su fino a dove avremmo dovuto spingerci. Non è che non ci fosse tensione o preoccupazione, eravamo andati troppo avanti, eravamo troppo vicini alla meta e, una volta superata la linea d’aria di Alessandria di Egitto, nessuno aveva più alcuna intenzione di fare un passo indietro.
La preoccupazione c’era, ma aveva imparato a camminarci accanto senza guidarci: sapevamo che il mare non assolve e il potere non perdona, e proprio per questo il nostro “avanti” è diventato irreversibile.
Eppure, non eravamo dei kamikaze o degli intrepidi, alcuni sicuramente avevano motivazioni sufficientemente forti ad essere pronti a tutto, ma la maggior parte di quei quasi 400 sulle barche erano persone normali. Persone che avevano lavorato tutta la vita o che si arrabattavano tra un lavoro e l’altro.
Persone che nel frattempo l’avevano perso, altri che avevano dovuto allungare le ferie. Persone che fino al giorno prima davano in tanti modi il loro piccolo contributo per cercare di creare un mondo migliore, chi lo faceva a scuola con i suoi studenti, chi parlava a milioni di follower, chi bruciava dentro dall’idea di dover fare qualcosa per fermare quello che stava succedendo a Gaza.
Eravamo la somma di vite comuni con un’idea ostinata: che la normalità, quando tace davanti all’ingiustizia, diventa complice. Per questo le nostre mani ordinarie hanno fatto una scelta straordinaria.
Perché eravamo lì
Da Creta in poi, mi sarei chiesta spesso perché ero lì. E la risposta più sincera che riuscivo a darmi è che Gaza è una di quelle storie dove raccontare non bastava. Dove la tua voce non è mai abbastanza e dove il racconto di quello che stava accadendo non sarebbe mai stato esaustivo.
Decine di barche, 44 nazioni.
Lo avevo già vissuto con l’Afghanistan, arriva un momento in cui bisogna posare la penna e, se necessario, usare il tuo corpo per raccontare una storia di cui saremmo stati costretti a diventare parte, cosa che un giornalista non ama mai, ma che, a volte, è imprescindibile da quello che si deve fare.
Ci sono frasi che non entrano in nessuna scaletta e verità che non trovano spazio in un palinsesto: allora ci metti il corpo, lo metti tra la menzogna e chi la subisce, e accetti il prezzo.
Ci sono storie che definiscono quello che sei, questa è stata una di quelle. E poi, veterana del racconto del conflitto israelopalestinese, ma soprattutto delle guerre degli ultimi 30 anni, immaginavo di poter dare un contributo.
Ma la verità è che dovevo fare qualcosa. Per tutti noi era così. Raccontare nel notiziario di Radio Bullets, da più di 700 giorni, un genocidio dove non potevo entrare da giornalista internazionale mi stava logorando.
Il microfono è diventato un’arma spuntata, la voce un’onda corta: serviva più mare, più rischio, più prossimità alla ferita.
L’anno scorso ero stata in Cisgiordania, ma ancora non era abbastanza.
E non potevo sopportare che i colleghi palestinesi continuassero a morire, insieme alle loro famiglie, persone che avevo conosciuto, con le quali avevo lavorato e che ora erano vittime, prima ancora dei bombardamenti, della diffamazione precisa, puntale e studiata della propaganda di Israele che li designava in terroristi, militanti, affiliati di Hamas senza che noi potessimo contrastarla.
La calunnia è un ordigno silenzioso: non lascia crateri nell’asfalto, ma buche nella memoria. E noi eravamo lì per riempirle di fatti e nomi.
Un po’ perché non potevamo non essere lì e un po’ perché i filosionisti erano talmente forti e ben inseriti che io e quelli che come me, che per anni raccontavamo il conflitto, siamo stati cancellati con un colpo di spazzola.
Cancellati dalle prime pagine, non dalla coscienza. E la coscienza, quando insiste, diventa rotta di navigazione.
Per questo a metà agosto ho detto a Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla, che sarei salita a bordo.
Il fatto che i giornalisti indipendenti fossero pochi non mi ha impensierito più di tanto, so che il mainstream era nella rete di un racconto completamente sbilanciato dall’altra parte per poter mettere piede su una barca che era fatta di attivisti, giornalisti indipendenti, avvocati e sanitari impegnati, accademici e politici di opposizione.
Non ho pensato troppo alle conseguenze, alla diffamazione di giornali che ci avrebbero attaccato come sei noi fossimo un problema e non una soluzione, come se avessimo anche lontanamente una qualsiasi forma di fascinazione verso la violenza.
La mia storia parla per me. Le storie e le persone che ho raccontato.
Perfino nei soldati avevo scavato per trovare un’umanità che sapevo doveva esserci, fino a che mi sono imbattuta in quelli israeliani, o nei militanti dell’Isis o nei talebani.
Non è coraggio: è mestiere, è etica, è testardaggine nel cercare il volto umano anche quando chi lo indossa ha scelto di coprirlo.
Ho sempre pensato che, quando si supera il limite del buon senso e si scivola nell’antro del radicalismo, non c’è più colore, nazione, religione che tenga. È solo la fine della ragione. È la disumanizzazione servita come antipasto.
È quello che succede in tanti posti del mondo, ma che stavamo assistendo in diretta nella Striscia di Gaza da due anni. E non era accettabile. Soprattutto perché, fossero stati altri, ad Israele, comunque un barlume di contrasto, minacce, lamentele, sanzioni, ci sarebbero state.
Israele, invece, ha viaggiato impunemente per decenni, ma gli ultimi 24 mesi sono stati l’azione delirante di uno Stato verso un popolo, dove non solo sono state violate sistematicamente tutte le leggi del diritto e degli essere umani, ma è stato agevolato, accettato, sostenuto da quelli che una volta erano i paladini dei diritti, quelli che esportavano democrazia, quelli che dicevano che le donne dovevano emanciparsi, quelli che oggi pensano più ai loro interessi economici che al proprio popolo.
Il vocabolario dei diritti è stato piegato come latta; le parole “sicurezza” e “ordine” usate come scudi per coprire la resa della politica.
Dove niente viene fatto per migliorare il benessere delle persone della propria nazione. È come se ci fosse stato un capovolgimento dell’idea della politica a favore di affari e amicizie, come se neanche l’apparenza contasse più o fossero stati sdoganati i peggiori istinti. Non ci sono più regole, saltano i rituali come quello di sottoporsi alle domande dei giornalisti o alle critiche degli analisti. Si compra e ci si posiziona.
Non si ha più imbarazzo a farsi chiamare fascisti o a dire che il politically correct non è più di moda. L’atteggiamento superiore, offensivo, viene sdoganato e di conseguenza la violenza dilaga.
Non un bel clima. La gente guarda e non fa nulla. È come se si vivesse nel tepore che non riusciamo a contrastare, non si vota, non si manifesta, non si legge, non si parla. Si scrolla, ci si occupa delle proprie cose, l’altro è un problema al proprio quieto vivere, piuttosto che una risorsa.
La democrazia senza partecipazione è un guscio vuoto: suona ancora, ma non protegge più nessuno.
Il mondo diventa ogni giorno più piccolo. Chi se ne importa delle afghane che chiedono di andare a scuola e lavorare come da qualsiasi parte.
Chi se ne importa delle iraniane che chiedono vita e libertà. Chi se ne importa dei sudanesi che vivono nella peggiore crisi umanitaria al mondo. Chi se ne frega di quello che vuole un popolo quando le elezioni vengono controllate o quando sono le armi, che spesso forniamo noi, a parlare.
Ci vestiamo con quel “chi se ne frega” che non è altro che quella indifferenza con la quale siamo andati a nozze per troppo tempo. Per quanto alcuni facciano, tutti gli altri sono intorpiditi dalla mancanza di speranza, dal credere che non si possa cambiare niente, dal fatto che più si è informati, più ci si dispiace vivere.
Ma l’indifferenza non è neutra: è un vento contrario. E controvento, a volte, si impara a navigare meglio.
Anche per questo salirò sul Morgana. Perché, come altre volte mi è accaduto, sono le scelte che prendiamo che fanno di noi le persone che siamo.
A volte basta un sì pronunciato in un porto per cambiare la traiettoria di una vita intera.
Vita a bordo

Saremmo dovuti partire il 4 settembre, dopo un paio di giorni di training ad Augusta. Non accadrà nulla per quasi dieci giorni perché le barche partite il 31 agosto da Barcellona e partite per Tunisi, dove dovevano unirsi alle altre, restano bloccate per un attacco di droni mentre sono in rada. Colpiti in acque nazionali da Israele che ammetterà l’attacco solo qualche settimana dopo.
Non ci sarà nessuna conseguenza. Nessuno Stato darà neanche un buffettino per dire “così però non si fa”. Il secondo nome di Israele è impunità.
Quell’assenza di reazione pesa più del boato delle bombe: è il silenzio istituzionale che ti dice quanto vale la tua vita in mare.
In realtà partiremo il 13 dopo una conferenza stampa a Siracusa dove, per la prima volta, salgo su una barca vela con 8 estranei con i quali avrei dovuto condividere una decina di giorni di viaggio.
La decina di giorni poi diventerà praticamente quasi il doppio perché ci fermeremo quasi subito a Portopalo, dove trascorreremo giorni in rada in attesa delle barche da Tunisi.
Stare fermi in barca è estenuante, anche se l’equipaggio è variegato e cortese. Ci conosciamo appena, solo qualche giorno fa, non sapevo dell’esistenza di nessuno di loro, a parte Maria Elena e ora siamo intrappolati in 12 metri e galleggiano sul mare.
Per una abituata a vivere da sola, è già una prova. Mi ritrovo a dividere una cabina con Maria Elena e Benedetta. Siamo sommerse di salviettine per pulirci perché il capitano da subito ci dice che l’acqua dobbiamo conservarla, quindi ci si lava in mare solo se siamo fermi.
Il bagno è minuscolo, ci vuole una laurea in ingegneria per tirare lo sciacquone che non si tira, ma si pompa, ma poi bisogna bloccarlo, altrimenti l’acqua torna su, cosa che abbiamo imparato a nostre spese.
La cambusa vegana

Non so chi sia il genio che ha riempito una barca di fagioli, ceci e noccioline, ma se non avessimo avuto la galera israeliana, forse qualche accidente ben indirizzato lo avrei mandato.
Scopro che sulle barche le cucine sono basculanti, che quando sei fermo e ancorato puoi fare facilmente un sacco di cose, che invece non puoi neanche provare a fare quando sei in movimento. Perché sbatti e ti aggrappi ovunque. Dopo tre giorni avevo più lividi che dopo una rovinosa caduta in Afghanistan.
Il mare ti educa alla misura delle cose: l’acqua, lo spazio, il sonno. E alla fine capisci che la libertà, in dodici metri, non è mai stata così vasta.
All’inizio cerchiamo di essere ordinati, lo spazio è poco, siamo tanti, abbiamo le scatole degli aiuti, le bottiglie d’acqua, il gasolio, il mangiare per noi. Siamo puntini pieni su un mare alla fine di un’estate ancora calda. Si sta bene anche se il desiderio di una doccia è costante.
Ogni oggetto ha un posto, ogni gesto un tempo: la disciplina salva più della fortuna. Ma siamo umani, non durerà molto.
L’equipaggio della mia barca a vela, la Morgana, è eterogeneo, c’è il capitano Cesare detto il bronzo della flotilla, il vice Carlo Alberto che insieme al Senatore Croatti fanno due romagnoli in pochi metri, l’europarlamentare Benedetta, l’infermiere di Alcamo, che appena saliti ci dice “Mi prenderò cura di voi”, senza sapere che lo avrebbero chiamato da ogni barca mentre lottava contro il mal di mare.

Poi c’è un’avvocata per i diritti umani e una giornalista turca, Semanour, entrambe parlano quasi niente inglese, ci capiamo usando i traduttori dei telefoni, di conseguenza parliamo poco e solo quando è necessario dare istruzione.
Molto velocemente cominciamo a conoscerci, ovviamente i difetti sono i primi ad uscire, ma diventano anche risorse, ogni tanto ci si irrita, ma in realtà non ci si arrabbia quasi mai, almeno fino alla fine.
In mare i caratteri fanno attrito e poi si lucidano: alla fine brillano, come il metallo dopo la ruggine.
La missione è importante, siamo fermi a migliaia di chilometri da Gaza e conta solo quello. Le nostre giornate ferme sono scandite dal tramonto e dall’alba. All’inizio è tutto suggestivo, il mare, la poesia, poi quando partiremo, e vedremo il vomito che vola da una parte all’altra della barca, tutto diventerà meno romantico.
Dopo un’attesa che sembrava infinita, finalmente partiamo.
È incredibile vedere una flotta intera che sfreccia sul mare, la notte le onde sono alte, il vento soffia forte. Ti muovi e sbatti contro tutto. Dribli nel vomito degli altri, scoprendo che solo il capitano, il vice e io non soffriamo il mare.
Potevo immaginarlo, tutti i voli tattici che avevo fatto in Afghanistan ti lasciano con una sensazione simile che a me era piaciuta molto mentre c’erano militari che rimettevano l’anima. Credo sia un dono quello di stare bene sempre, in qualsiasi situazione ci si trovi.
Quando il mare decide di provarci, rispondo con la fermezza di chi ha già visto cieli più bassi e notti più rumorose.
Puntiamo verso la Grecia, la velocità non è altissima perché dobbiamo tenere una formazione e perché alcune barche sono meno buone e probabilmente non ce la faranno mai ad arrivare vicino a Gaza.
Durante il giorno si lavora, siamo una barca molto connessa, una portavoce, due giornalisti, due parlamentari, un’avvocata, parliamo sui social, scriviamo articoli, partecipiamo a trasmissioni. Benedetta passa buona parte del suo tempo a cercare le cose che perde, dalle cuffie al cappellino, Croatti, scropriremo presto e lo useremo a nostro vantaggio, quando è nervoso, pulisce.
Il capitano e il vice si danno il cambio nella guida, mentre gli altri a turno o si dopano con la xamamina o vomitano come se non ci fosse un domani.
Siamo un ufficio instabile con pareti d’acqua: le notizie entrano, il vento impagina, la rotta manda in stampa.
La sera qualcuno cucina, di solito pasta o qualche miscuglio di scatolette, dopo quasi 20 giorni, una fetta biscottata dolce con un po’ di sale grosso, olio e un’acciuga di quelle gelosamente conservate ci sembrerà una prelibatezza.
Ma manca ancora molto a quei 18 giorni perché tutto cambierà da lì a poco.
In mare impari che il lusso è un morso di pane quando hai ancora qualcosa da dire. Siamo a qualche decina di miglia di distanza da Creta, il sole ci brucia la pelle e io ho già assunto un’abbronzatura da operaia.
Sto la maggior parte del tempo seduta all’esterno, sotto un telo che fa ombra ma non abbastanza, e scrivo, leggo, faccio collegamenti, chiacchiero con i capitani, mi becco con l’infermiere che ha quei modi affettuosi che non sopporto, mi controllo sapendo che sarebbe un attimo buttarlo in mare.
La franchezza salva più della cortesia: in mare le maschere scivolano con la salsedine.
Da Creta a Gaza sono 450 miglia più o meno, circa 6 giorni se non di più alla velocità in cui andiamo. Sappiamo che le flottiglie precedenti erano state intercettate a 150 miglia da Israele, quindi siamo ancora tranquilli.
Va tutto bene. Ma più andiamo avanti più la tensione sale. Da una parte il governo italiano che fa pressione per fermarci, cosa che non subiscono le altre nazionalità, gli amici spagnoli e malesi sono sostenuti dai loro governi, anche i turchi, noi come gli americani no. Anzi siamo una spina nel fianco.
Ogni miglio è un chiodo piantato nella coscienza dei governi: fa rumore, ma fingono di non sentirlo. Lo sente la gente. E noi sentiamo loro.
Subiamo una campagna di diffamazione su alcuni giornali senza precedenti, o forse lo fanno sempre ma finché non sei presa in causa non ci pensi. Ma più ci attaccano, più la gente sembra risvegliarsi, questo gruppo di persone dalle vite che più diverse non potrebbero essere sta risvegliando l’Italia.
Ci siamo solo messi in acqua con l’obiettivo poco realizzabile di andare a Gaza a portare una manciata di aiuti, ma era esattamente quello che serviva, non per sfamare i poveri palestinesi abbandonati dalle istituzioni del mondo, ma per sigillare quello scollamento tra il nostro governo e il volere della gente.
E la gente diceva basta. Le orecchie da mercante del governo sono diventate orecchioni e più noi andavamo avanti più quel filo che ci legava alla società civile a casa diventava stretto. Non eravamo solo noi in mare, c’erano centinaia di migliaia di persone.
Eravamo pochi, ma con dietro un coro: e un coro, quando trova il tono, rompe i vetri del palazzo.
Poi è arrivata la notte di Creta

Silenziosa, bellissima, ingannevole. Il mare era calmo come se volesse farci credere che nulla sarebbe accaduto. Il vento soffiava piano, le vele gonfie di fiducia, le luci lontane delle altre barche come costellazioni sparse su un orizzonte scuro. Siamo lontani, lontani da Gaza.
Siamo tranquilli, ci aspettiamo un attacco vicino all’Egitto, eppure nessuno parla troppo nella notte del 23, ognuno chiuso nel proprio pensiero, in quell’attesa che sa di presagio.
Ho imparato che le notti belle hanno un modo feroce di rompersi: senza preavviso, senza pietà.
Eravamo a una cinquantina di miglia da Creta quando il primo ronzio ha tagliato il cielo. Lo abbiamo sentito tutti, ma nessuno ha osato dirlo.
Non era il mare, non era il vento. Era un suono meccanico, intermittente, come un insetto metallico che ti gira intorno e ti misura il respiro. Poi il secondo, più vicino, più insistente. Il capitano ha spento le luci di coperta, qualcuno ha messo mano al telefono, ma la rete era già disturbata.
Il mare si è fatto nero, denso. Croatti è la nostra vedetta, puntava il dito e ci indicava dove sono. “Si avvicina, si avvicina, è su di noi”. E poi il silenzio. Il cielo non era più cielo: era un soffitto basso pieno di occhi.
Siamo tutti seduti all’esterno con i nostri zainetti d’emergenza pronti, i giubbotti salvagenti scomodi che ci spingono sul collo. Stiamo fermi nei posti assegnati. Facciamo video perché sappiamo che i nostri filmati saranno prove.
Ogni fotogramma un’àncora, ogni secondo registrato un testimone che non può essere ammutolito.
Poi il primo lampo
Una scia luminosa ha attraversato l’aria e si è conficcata nell’acqua a poche decine di metri da noi. Il silenzio è stato collettivo, un misto di incredulità pura.
Ma nessuno ha fiatato. 20 minuti. Il secondo colpo è arrivato poco dopo. Eravamo nel mirino come altre barche. Raggi di luce che scendevano verso di noi, senza che potessimo fare assolutamente niente se non continuare a navigare.
Contare i minuti tra un colpo e l’altro è come contare i battiti del proprio cuore: capisci che sei vivo perché fa male.
Il terzo colpo è stato il più vicino. Ha sfiorato la poppa e squarciato la vela come una lama. Un sibilo, poi il vento che entra violento nel taglio, come se il mare avesse deciso di urlare anche lui.
La Morgana ha tremato, oscillando nel buio, mentre le altre barche rispondevano via radio con frammenti di frasi, voci rotte, interferenze, preghiere. Qualcuno grida “Mayday, mayday”.
Abbiamo sentito il calore, l’odore acre del metallo e del carburante, la sensazione di essere dentro un bersaglio invisibile. Il capitano teneva fissa la rotta, il vice correva a controllare la vela al buio, Benedetta cercava di coprire le orecchie e continuare i collegamenti, io tenevo la telecamera accesa anche se il giubbetto mi impediva qualsiasi movimento.
Non volevo smettere di documentare. Non potevo. Il mare era una trappola, la notte un imbuto senza uscita.
Quando il rumore dei droni si è allontanato, siamo rimasti in silenzio, muti, a guardarci. Non servivano parole. Eravamo stati colpiti. Tre volte. In acque internazionali. Da chi dice di difendersi e, invece, attacca.
L’aritmetica dell’impunità torna sempre: tre colpi, zero conseguenze.
Eravamo ancora lì, tutti incredibilmente tranquilli, con la vela ferita come un animale sanguinante. Carlo Alberto e Cesare hanno dovuto aspettare l’alba per vedere i danni, mentre io e Benedetta pensavamo che fosse proprio ora di andare a dormire.
La luna era alta e sembrava guardarci con pietà. Ogni tanto un’altra luce si accendeva in cielo e ci immobilizzava: droni che ci seguivano, che ci studiavano, che decidevano se colpirci ancora o lasciarci andare. La pietà della luna non scalda, ma illumina: e a volte basta.
Non abbiamo dormito. Nessuno ha dormito. Il sonno, quella notte, era un lusso indecente.
C’era un odore di tensione mescolata al sale e all’odore della bottarga che avevamo mangiato quella sera, e dentro ognuno di noi il pensiero che quella notte avrebbe dovuto essere ancora lontana. Ma nessuno lo ha detto. Le frasi trattenute pesano come ancore: ti tengono fermo, ti impediscono di sbriciolarti.
Quando è arrivata l’alba, con la sua luce gialla e crudele, abbiamo contato i danni. La vela squarciata, un altro capitano mezzo sordo, un’altra barca in avaria. La flotilla era stata colpita. Ma il mondo della politica non aveva fiatato. Le istituzioni tengono il volume basso proprio quando dovrebbero alzarlo.

In quel momento abbiamo capito davvero cosa significava essere parte di quella missione: non solo sfidare un blocco, ma guardare in faccia l’arroganza del potere e dire “ci siamo ancora”. “Non ci avete fermato”.
Resistere è una parola semplice: vale tanto quanto costa. Da quella notte, il mare non è più stato lo stesso. Ogni onda ha preso a bussare come se portasse notizie da consegnare a chi non vuole ascoltare.
Ogni onda portava con sé un’eco di metallo, ogni silenzio il ricordo di quel ronzio che ti si infila sotto la pelle. Ma anche la consapevolezza che nessuno di noi avrebbe più potuto tirarsi indietro. Eravamo troppo vicini alla verità per voltare la prua.
E la Morgana, ferita ma viva, continuava a navigare. Ma non saremmo rimasti tutti. Il capitano e l’infermiere decidono di scendere. Maria Elena anche, perché la scuola dove insegna la chiama. La povera avvocata turca verrà colpita dai calcoli renali ed evacuata dalla barca di Emergency.
Ogni addio in mare è breve e definitivo: salutare è come recidere una cima
Ci dispiace vederli andare via dopo quello che abbiamo passato, ma non si può costringere nessuno a restare. La flotilla è una scelta, per questo è forte. Al loro posto salgono José, genovese del Calp, Miguel un portoghese che lavora sulle barche della Seawatch e insegna sociologia, e un giornalista turco che ovviamente non parla inglese, ma gesticola benissimo.
Le barche cambiano equipaggio come il mare cambia umore: l’essenziale è solo la direzione.
Dopo i droni ci siamo diretti a tutta velocità in acque nazionali greche pensando che almeno gli israeliani non avrebbero osato sfidare acque territoriali di una nazione, ma ormai eravamo pronti a tutto.
Stiamo in rada qualche giorno nella baia di un’isoletta disabitata. I tempi si allungano. Ma la manutenzione è fondamentale perché sappiamo che la prossima tappa sarà l’abbordaggio e da lì in poi non controlleremo più niente e nessuno saprà più nulla di noi.
L’abbordaggio

Quando raggiungiamo le 150 miglia, più o meno, all’altezza di Alessandria d’Egitto, le tre navi militari — italiana, spagnola e turca — che ci avevano seguito ci mollano proprio nel momento in cui sappiamo di averne più bisogno.
Non sono qui per proteggerci; sono qui per mostrare che il teatro internazionale continua a recitare la sua parte, mentre qualcun altro scrive le regole del gioco. La sensazione è quella di rimanere nude in mezzo al palcoscenico, sotto un riflettore che non perdona.
La diplomazia ci guarda, ma non ci vede: preferisce l’applauso alla responsabilità.
La mattina dell’abbordaggio si apre grigia, con un vento che non aiuta né il morale né la navigazione. Le onde sono una successione di colpi lenti, come se il mare volesse prendere tempo. Poi, all’improvviso, tutto si accelera, non appena scende il tramonto: dall’orizzonte spuntano scafi neri che tagliano l’acqua come lame. Le motovedette si muovono in formazione, ordinate, efficaci.
Le luci sono l’unica cosa che contrasta con il grigio: segnali netti che, in quel momento, sembrano la manifestazione materiale di una decisione già presa altrove. È la grammatica del potere: apparire improvviso, parlare poco, colpire preciso.
La radio esplode in comandi incomprensibili e ordini che somigliano a ultimatum. Dall’altra parte sentiamo voci che per noi sono autorità, per loro solo esercizio di potere. Le luci abbaglianti ci colpiscono come fari di tribunale; per un attimo ci sentiamo alla sbarra.
E poi i gommoni: minuscoli, rapidi, pieni di figure incappucciate che saltano come ombre su e giù per le fiancate. È tutto così veloce che sembra che stiamo vivendo un film. Ma questo non è cinema: qui i titoli di coda non salvano nessuno.
Sul ponte della Morgana c’è un silenzio violento, rotto solo dal rumore degli scarponi e dalla vista degli M16 che tengono puntati verso di noi. Sentiamo ordini urlati e vediamo mani che non esitano.
Mi torna in mente il messaggio di Thiago: “Siamo una missione non violenta”. In quel momento la parola suona come una preghiera più che come una definizione operativa. Ripeto “non violenti” come un rosario, contando le raffiche del respiro.
Ci dicono di non reagire. È un ordine che salva e che punisce: salva perché evita azioni che avrebbero potuto degenerare in tragedia; punisce perché ti leva la possibilità di difenderti.
Abbiamo appena in tempo buttato i cellulari in mare. Non abbiamo più voce. Perquisiscono noi, la nave. Distruggono a calci il satellitare al quale ci connettevamo. Le telecamere. È un modo di spegnere la voce prima ancora di calpestarla.
“Hai avuto paura?”, mi chiederanno spesso. La risposta è no. Forse siamo preparati, forse avevo vissuto cose peggiori in passato, forse il gruppo forte e coeso che siamo ci impedisce di spaventarci, forse sono io che vedo quello che accade come se fossi esterna al mio corpo.
Ma il silenzio preoccupa. Penso alle immagini che avevo in mano, ai racconti, ai contatti con i colleghi nelle zone di guerra: tutto può essere cancellato con un gesto chirurgico. È un furto di memoria. Spegnere gli occhi elettronici è più facile che spegnere quelli umani: per questo insistono.
Ricordo la sensazione della prua che si riempie di uomini in divisa, volti coperti, occhi solo fenditure che scrutano. Ci fanno scendere, ci dicono di stare lì. A noi scende la tensione. Siamo la terza barca fermata, a 48 miglia di Gaza. Piano, piano ci prenderanno tutti.
Su altre barche alcuni vengono colpiti dai cannoni d’acqua, altri vengono legati con le fascette di plastica. L’acqua come arma, la plastica come sigillo: due materie neutre piegate alla forza.
I pirati col distintivo parlano poco. Agiscono con una professionalità fredda che somiglia a una coreografia: entrano, neutralizzano, raccolgono, portano via. A volte, tra un ordine e l’altro, ci sono frammenti di conversazione: “Documenti, documenti”, “Ispezione”, “Comando centrale”. Nessuna parola umana che giustifichi il nervosismo che ci mordicchia le costole.
Le barche della flotta vengono isolate, sono i soldati a guidarle, ci sono ancora dieci ore di viaggio, a noi non funziona neanche il pilota automatico.
Ci trascinano come trofei, ma il mare rifiuta di farsi complice: sbatte, scuote, ricorda.
Nel caos, emergono atti di coraggio piccoli e insanabili: chi nasconde una scheda di memoria nello stivale, chi riesce a strappare via una pagina di quaderno e a passarla a un altro compagno. Ci sono gesti che sono come amuleti; non servono per cambiare il presente, servono per non perdere la propria storia.
Quando salgo sul ponte della mia barca per l’ultima volta prima del trasferimento, vedo Benedetta con lo sguardo fisso. Sa che lei e il senatore non resteranno con noi.
Ma non siamo neanche minimamente arrabbiati con loro che hanno il passaporto diplomatico: chi resta e chi se ne va sono due forme di responsabilità uguali. Ora saranno loro la nostra voce.
Quel giorno i nostri sguardi sono un sussurro che vale più di mille proclami: “Fate la vostra parte”, ci hanno detto con lo sguardo, e io ho capito che la nostra parte era resistere, testimoniando finché le forze non ci avessero staccato la penna dalle mani. In mare, la responsabilità ha molti volti: nessuno più nobile di un altro, se guarda nella stessa direzione.
Siamo stati ammassati come merci, allineati sul ponte di una nave militare, con il mare che continuava a muoversi sotto di noi, indifferente.
Ci hanno fotografato, schedato, interrogato a freddo come se ci vedessero solo come numeri. Ci hanno tolto il diritto alla narrazione personale trasformandoci in caselle da barrare su un foglio. Quando diventi numero, l’unico modo per tornare persona è ricordare a memoria il tuo nome e quello degli altri.
Il trasferimento verso i centri di detenzione è stato una sequenza di attese: gommoni veloci, trasferimenti di notte, luci che si accendono e si spengono. La sensazione delle mani che stringevano i polsi, il freddo delle manette di plastica, l’odore del carburante dei gommoni che si mescolava al sapore del sale e alla stanchezza.
Ogni ora che passava allontanava la possibilità di controllare la situazione, ogni chilometro che ci separava dal mare che ci aveva accolto ci portava più vicino a spazi dove la nostra voce avrebbe potuto essere compressa.
Ecco cosa restava, alla fine: la consapevolezza che la violenza dell’atto non si limita al momento dell’abbordaggio o di quello che ci accadrà al porto o ancora di più in galera, ma si protrae nel tentativo di controllare la narrazione. Chi decide il racconto, decide le colpe: per questo ci vogliono muti.
Hanno preso i nostri dispositivi, ma non le nostre memorie; hanno chiuso i nostri canali, ma non la nostra lingua. Quello che non hanno potuto prevedere è che la storia ha sempre dei buchi, e nei buchi entrano le voci che non si arrendono. Le crepe sono passaggi: da lì filtrano luce e testimonianze.
Chiudendo gli occhi, nei giorni successivi, pensavo spesso alla scena dei giorni precedenti: alle mani che si allungavano, alle fascette che scattavano, al rumore degli scarponi.
E mi dicevo che le pagine sarebbero state fatte non solo di quello che ci è stato tolto, ma soprattutto di ciò che siamo riusciti a tenere. Perché questo è il paradosso di chi testimonia: più provano a fermarti, più forte diventa la spinta a raccontare.
Sono la detenuta numero 250. Il nostro crimine: un atto di umanità.
E se questa è colpa, la rivendico. E la riscrivo, riga dopo riga, finché il numero tornerà a essere nome. Il mio nome.
Potrebbe interessarti anche:
- Israele: torture in carcere
- GSF, Schiavulli: “Occhi su Gaza. Non siamo complici. Lo è la politica”
- GSF: gravi abusi sugli attivisti
- GSF: il rientro degli attivisti e delle attiviste
- Afghanistan: l’orrore delle prigioni femminili
- Gaza: spinta per votare il piano di ricostruzione mentre i palestinesi affrontano il maltempo
E se credi in un giornalismo indipendente, serio e che racconta il mondo recandosi sul posto, puoi darci una mano cliccando su Sostienici