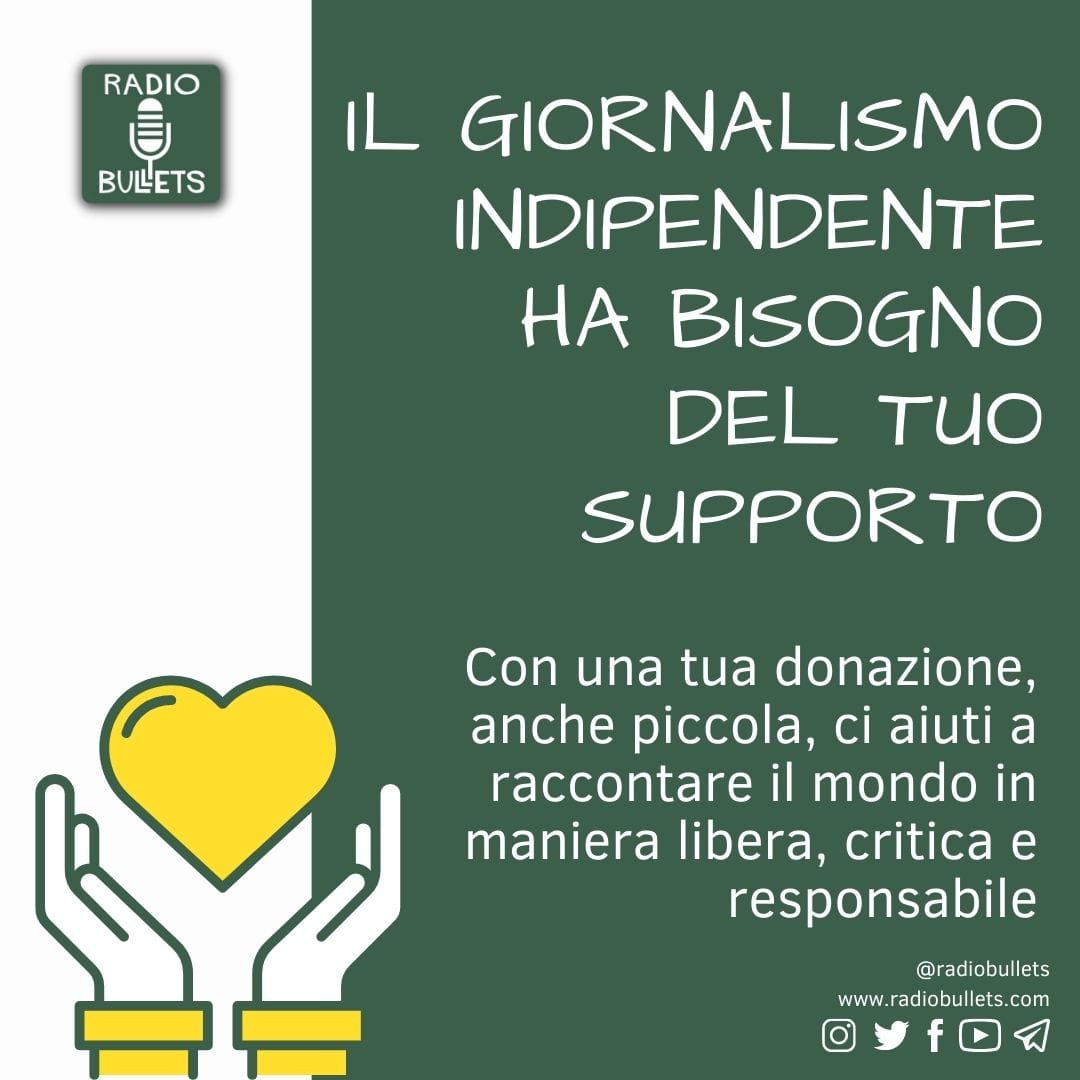L’Europa e la corsa al riarmo tra propaganda e velleitarismo
Scritto da Pasquale Angius in data Novembre 19, 2025
Ascolta il podcast
L’Europa in crisi spera di rilanciare l’economia con una nuova corsa al riarmo.
“Invasori, invasi e invasati”
Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, quando scoppiò la guerra in Ucraina, con sarcastica capacità di sintesi descrisse la situazione dicendo che c’erano tre categorie di persone: gli invasori, gli invasi e gli invasati.
Ovviamente gli invasori erano i russi e gli invasi gli ucraini.
Nella terza categoria, quella degli “invasati” c’era una nutrita e variegata combriccola di politicanti, giornalisti, studiosi e analisti o sedicenti tali che, infervorati dal clima bellico, incitavano le malconce armate ucraine a sconfiggere militarmente una potenza nucleare come la Russia.
Nell’ultima categoria spicca, sin dalle prime ore dopo l’invasione, la baronessa Ursula Von der Leyen, a capo di quel monumento all’incompetenza politica che è l’Unione Europea.
Probabilmente stanca di emanare noiose e irritanti direttive su come lasciare attaccati i tappi alle bottiglie di plastica, non vedeva l’ora di scatenarsi in qualcosa di molto più adrenalinico come un bel conflitto alle porte di casa.
A distanza di tre anni tutte le balle che ci hanno raccontato sinora sul conflitto ucraino stanno venendo al pettine, ma la nostra nobildonna, a conferma del fatto che spesso l’ambizione sopravanza di gran lunga il talento, con teutonica determinazione, prosegue nei suoi piani bellici ammonendo quegli smidollati degli europei, che se non si riarmano al più presto le feroci orde russe dilagheranno in Europa perché quel sanguinario di Putin non si fermerà all’Ucraina.
Il “nemico alle porte”
Chi ha il buongusto di leggere qualche libro di storia saprà che agitare lo spauracchio del “nemico alle porte” è sempre stata una delle armi propagandistiche più efficaci per imporre ai popoli riottosi le decisioni più sconsiderate.
La paura è un formidabile “instrumentum regni”, il modo migliore per zittire le obiezioni e le critiche.
Se è in gioco la sopravvivenza della nazione, della patria, del nostro popolo, della nostra libertà, non c’è più tempo per i sofismi, per le analisi accurate, per i ragionamenti, per i dubbi, per i compromessi.
Come diceva uno studioso tedesco, un certo Carl Schmitt, quando si comincia a sparare la realtà si semplifica, esistono due sole categorie, quella di “nemico”, chi mi spara addosso e quella di “amico”, chi non mi spara addosso. Il resto non conta più nulla.
La logica delle armi è proprio questa, quella di un mondo che si semplifica e diventa improvvisamente in bianco e nero, dove si perdono tutte le infinite sfumature di colore che la realtà solitamente ci propone.
La baronessa Ursula ha stabilito che i russi sono il nemico, il male da combattere e da sconfiggere, ora la prima domanda che sorgerebbe spontanea è: siamo proprio sicuri che i russi siano una minaccia vitale e immediata alla nostra sopravvivenza?
Siamo sicuri che non esista alcuna soluzione politica per fronteggiare l’indubbia aggressività russa?
Non cercheremo in questa sede di rispondere a queste domande di natura storica e politica ma intendiamo concentrarci sugli aspetti più strettamente economici del nuovo programma di riarmo approvato qualche mese fa dall’Unione Europea, il tanto decantato ReArm Europe.
Il nuovo piano ReArm Europe
Vediamo sinteticamente come dovrebbe funzionare il nuovo piano di riarmo.
ReArm Europe ha l’obiettivo di mobilitare in pochi anni 800 miliardi di Euro di nuove spese militari.
Circa 650 miliardi dovrebbero derivare dalla concessione ai singoli Paesi dell’Unione di aumentare le spese per armamenti dell’1,5% del proprio PIL ogni anno, derogando alle regole del Patto di Stabilità europeo.
A ciò si aggiunga che la Commissione emetterà obbligazioni per un importo di 150 miliardi di Euro che verranno prestati a condizioni molto agevolate agli Stati membri, sempre per acquisti di armamenti.
Verrebbero anche dirottati una parte dei fondi di coesione verso spese per la difesa e si consentirà alla Banca europea degli investimenti di destinare fondi per il comparto bellico, per creare un meccanismo comunitario che stimoli gli investimenti nella produzione di armamenti.
La corsa al riarmo non rilancia la manifattura europea
Quali sono i problemi?
Partiamo da una considerazione di carattere generale. Molti economisti ritengono che le spese militari non siano per un Paese necessariamente qualcosa di negativo o, per dirla in maniera alternativa, un modo improduttivo per impiegare risorse scarse.
Anzi, le spese militari possono far da volano all’intera economia e d’altronde ci sono diversi precedenti storici a conferma di questa teoria, a cominciare dagli Stati Uniti che, alla fine degli anni Trenta, non erano ancora usciti dalla recessione causata dalla crisi finanziaria del 1929.
L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’entrata del Paese nella Seconda guerra mondiale portò alla mobilitazione di tutte le risorse del Paese con enormi investimenti pubblici e soltanto così l’economia americana si riprese completamente, recuperando e superando i livelli di produzione e di reddito precedenti alla crisi.
L’idea quindi accarezzata da molti economisti, politici, analisti vari è che di fronte a una crisi strutturale del sistema industriale europeo, una corsa al riarmo possa rappresentare il nuovo volano per ridare slancio alla crescita economica.
L’Europa è rimasta indietro, grazie alle persistenti politiche di austerità, nella corsa verso le nuove tecnologie: dalle comunicazioni, ai satelliti, all’intelligenza artificiale, settori ormai presidiati da cinesi e americani.
L’Europa, varando uno scombicchierato piano di transizione alle tecnologie verdi, il famigerato Green Deal, è riuscita a mettere in crisi l’intero comparto automobilistico europeo senza, d’altro lato, riuscire a fermare la temibilissima concorrenza cinese sull’auto elettrica e tutte le tecnologie connesse.
Di fronte alla crisi del proprio sistema produttivo l’Europa pensa, o meglio si illude, di aver trovato in una nuova corsa agli armamenti la scorciatoia per fare ammenda di tutti gli errori e le idiozie degli ultimi vent’anni.
Ma le cose, purtroppo, non sono così semplici.
Gli armamenti moderni richiedono processi produttivi altamente specializzati e, quindi, non è facile e nemmeno automatico riconvertire produzioni per uso civile in produzioni per uso militare.
Inoltre, le produzioni belliche ad alta intensità tecnologica impiegano sempre meno manodopera.
Secondo analisi fatte da organismi come il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale il moltiplicatore delle spese belliche è oggi attorno allo 0,75 circa ma nel caso europeo, data la forte dipendenza dalle forniture statunitensi, si ridurrebbe allo 0,5.
Spieghiamo brevemente cosa si intende per moltiplicatore.
Ogni volta che c’è un aumento di spesa determinato da un aumento dei consumi, degli investimenti privati o della spesa pubblica si ha un effetto moltiplicativo sul PIL di un Paese.
Solitamente l’incremento del PIL generato da quella spesa è più che proporzionale rispetto alla spesa stessa, quindi si innesca un meccanismo virtuoso che spinge la crescita economica.
Facciamo un esempio. Se il governo italiano decide di comprare 100 nuovi caccia da combattimento affidando la commessa a una primaria azienda nazionale, questa azienda assumerà nuovo personale, attiverà la sua rete di fornitori per comprare materie prime, componentistica, software.
L’investimento governativo si tradurrà in nuovi salari che saranno utilizzati per acquistare nuovi beni di consumo, stimolando altri settori produttivi, ma cresceranno anche le tasse pagate dall’azienda produttrice perché ha aumentato il proprio fatturato come l’aumentano anche i fornitori di quella azienda, ma cresceranno anche i profitti e quindi i dividendi per gli azionisti e così via.
Quindi, la spinta iniziale data da quella spesa pubblica spinge la crescita come una palla di neve che, rotolando lungo un pendio, si ingrossa sempre di più.
Ma se, nel caso europeo, una parte consistente della nuova spesa pubblica finirà a fornitori statunitensi perché, per esempio, tutta l’avionica e i missili di quei caccia sono di produzione americana, l’effetto moltiplicatore sul PIL italiano sarà inferiore.
Stando così le cose, ogni Euro speso in Europa per finalità belliche si tradurrà in un aumento di soltanto 50 centesimi del PIL.
Se gli stessi soldi venissero spesi, per esempio, nel settore sanitario, dove il moltiplicare è 1,3/1,4, si avrebbe invece un aumento del PIL.
Quindi investire nel riamo non rappresenterà per l’Europa quel volano che può ridare slancio alla crescita della manifattura europea.
L’industria europea degli armamenti è troppo frammentata
Un secondo problema è la forte frammentazione dell’industria europea degli armamenti e la sua dipendenza molto stretta dalle forniture americane.
Il settore difesa in Europa è organizzato e concepito su base nazionale e la difesa comune è garantita dalla NATO, nella quale il ruolo statunitense è preponderante.
Il vero deterrente che ha l’Europa sono le basi militari americane sul proprio territorio, i circa 90.000 soldati statunitensi stanziati in Europa e l’ombrello nucleare statunitense.
Dagli Stati Uniti dipendono anche funzioni oggi essenziali per un’efficace difesa militare a cominciare dalle reti di intelligence, dai sistemi satellitari alle piattaforme per il trasporto, per esempio i grandi aerei cargo, alle tecnologie informatiche per l’acquisizione e la selezione di dati e informazioni, ai sistemi per la difesa aerea, ai missili convenzionali.
Ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti è molto complicato e richiederebbe investimenti molto più consistenti che non gli 800 miliardi del ReArm Europe e tempistiche medio-lunghe.
Le industrie belliche europee, organizzate su base nazionale sono già al limite delle loro capacità produttive per sostenere lo sforzo bellico ucraino.
Per fare un esempio pratico, nel 2022 il governo tedesco ha ordinato 130 nuovi carri armati Leopard, la consegna prevista è per il 2030!
Tempistiche che, tra l’altro, fanno a pugni con la presunta imminenza della minaccia russa!
La standardizzazione degli armamenti
Un altro grande problema dell’industria bellica europea è il basso grado di integrazione e di standardizzazione degli armamenti.
In riferimento sempre al conflitto ucraino, mentre gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev un unico modello di carro armato, gli europei ne hanno forniti sette, ma nei diversi eserciti europei ce ne sono ben dodici.
Ogni modello ha prestazioni diverse, magari anche munizionamenti diversi, necessita di addestramento del personale che dovrà usare quel particolare modello, ha catene di fornitura per le parti di ricambio diverse dagli altri modelli e via di questo passo.
Quindi, in sintesi, la prima cosa che dovrebbero fare gli europei, se volessero migliorare l’efficienza delle loro difese e ridurre la dipendenza dall’apparato militare-industriale statunitense, dovrebbe essere coordinare e integrare meglio le proprie industrie militari, e standardizzare gli armamenti prima ancora di lanciarsi in ambiziosi programmi di investimento.
Ovviamente queste cose sono facili a dirsi e difficili da farsi, perché le industrie belliche sono strettamente legate alla sovranità politica di ogni Paese, attorno ad esse ruotano interessi e lobby potentissime che condizionano la politica.
I Paesi europei, soprattutto quelli più grandi, hanno importanti aziende nel settore della difesa – pensiamo alla francese Thales, alla tedesca Rheinmetall o al gruppo italiano Leonardo – ma questi produttori realizzano più del 70% dei loro fatturati in ambito nazionale e quindi è molto difficile convincerli a rinunciare alle rendite quasi monopolistiche di cui godono nei rispettivi mercati nazionali per procedere ad una standardizzazione degli armamenti.
La difesa è l’ultimo baluardo della sovranità politica, la possibilità per gli europei di dotarsi di una difesa comune prevederebbe la capacità di muoversi verso una vera e propria integrazione politica ma non sembra che allo stato attuale ci siano le condizioni per fare questo salto e non ci sono nemmeno leader europei che lo propongono, anzi l’esatto contrario.
Il livello di entropia all’interno dell’Unione aumenta, le forze disgregatrici si rafforzano, le leadership europee sono deboli per non dire che sono assolutamente incapaci, le pressioni per favorire la disgregazione dell’Unione Europa, che provengono da un lato da parte della Russia e dall’altro dall’America di Trump, si fanno sempre più forti.
Decidere di finanziare nuove spese belliche senza aver definito prima una strategia comune di difesa e una razionalizzazione dell’esistente potrebbe produrre ulteriori sprechi e inefficienze ma altre perplessità nascono dalle modalità di finanziamento di questo piano di riarmo.
In pratica si dice ai Paesi europei, riarmatevi e le relative spese non verranno contabilizzate nei rigidi parametri di bilancio stabiliti dall’Unione Europea.
Ma in un contesto nel quale il livello di indebitamento complessivo e quindi di capacità di spesa dei vari Paesi dell’Unione è diversa, questo significa che ci saranno Paesi che possono spendere e altri che non possono spendere.
Se la Germania ha margine per aumentare il suo debito pubblico, l’Italia, per esempio, di margini non ne ha perché il nostro debito è già troppo alto, sfiora i 3.100 miliardi di Euro.
Tutto ciò significa che l’Italia, non potendo aumentare il debito pubblico, dovrebbe ridurre le spese per altre necessità: sanità, istruzione, pensioni, assistenza sociale.
Infine, c’è un ultimo paradosso.
L’Unione Europea con il Green Deal che forzava con tempistiche irrealistiche il passaggio all’elettrico ha messo in crisi l’intero comparto automobilistico europeo, ma con il ReArm Europe finanzia armamenti che consumano quantità industriali di combustibili fossili.
Carnivori versus erbivori
Il presidente francese Macron disse che in un mondo di carnivori gli erbivori hanno vita breve, per sottolineare che in un contesto politico internazionale profondamente mutato il pacifismo senza sé e senza ma finisce per essere pura retorica perché non disinnesca le minacce reali.
Ma affrontare i pericoli di un mondo che si sta imbarbarendo non può prescindere da una analisi puntuale delle reali minacce, da una definizione precisa degli obiettivi che si vogliono raggiungere e da una commisurazione realistica dei mezzi con i fini altrimenti dalla retorica pacifista si passa facilmente alla retorica bellicista e la seconda è di gran lunga più pericolosa della prima.
In un’epoca storica nella quale torna di moda il fascino per i leader politici forti, indossare l’elmetto, assumere pose marziali e straparlare di guerre e riarmo dà l’illusione ai malandati politici europei di apparire anch’essi forti e determinati, sperando di convincere i loro elettori rimbesuiti dalla propaganda e da un sistema informativo che, sempre più spesso, invece di svolgere il ruolo di cane da guardia del potere preferisce accoccolarsi nel più confortevole ruolo di cane da salotto.
Potrebbe interessarti anche:
- La crisi dell’ordine globale tra economia e geopolitica
- La crisi della globalizzazione
- Lo sviluppo della globalizzazione
- La guerra dei dazi e la strategia di Trump
E se credi in un giornalismo indipendente, serio e che racconta il mondo recandosi sul posto, puoi darci una mano cliccando su Sostienici