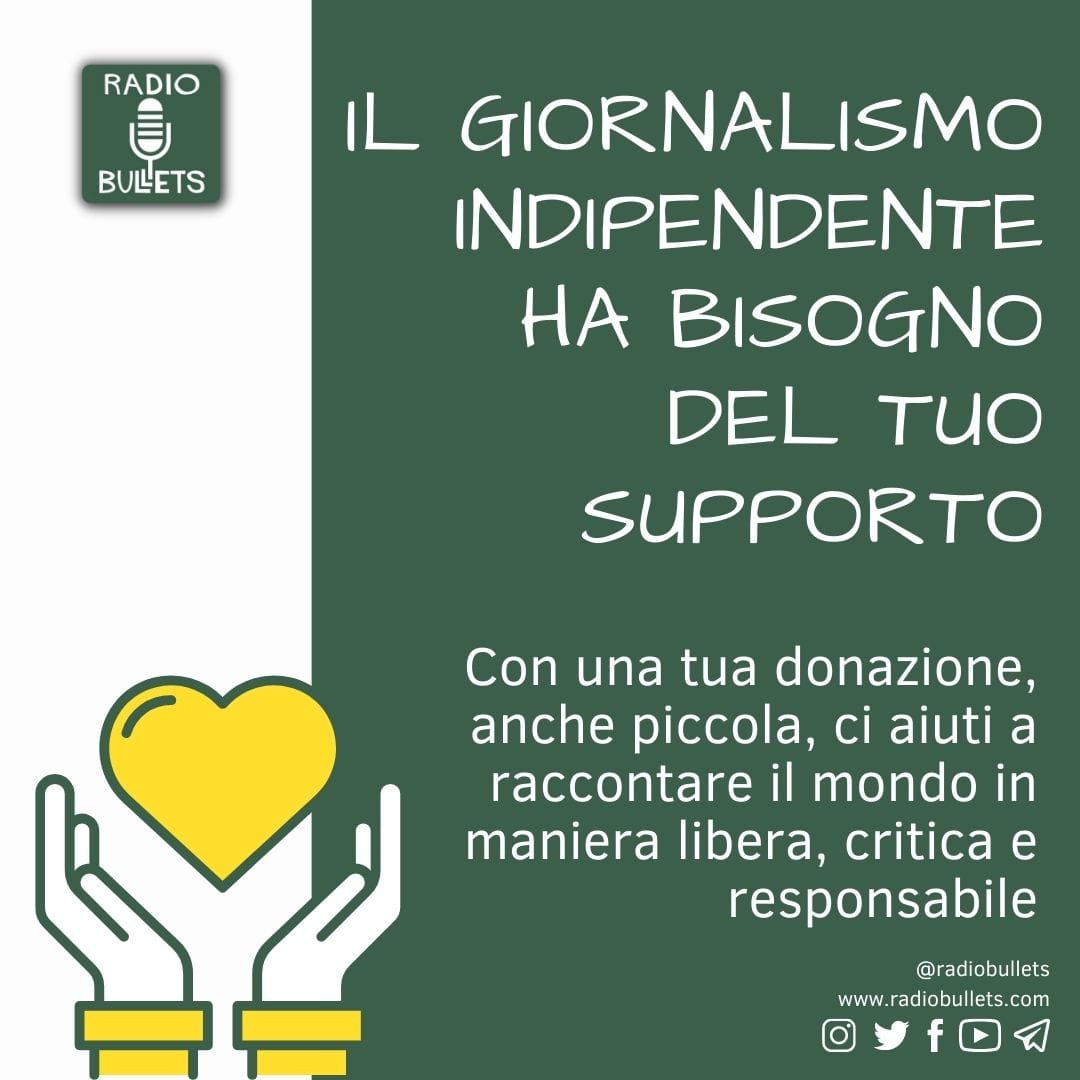La guerra e il giornalismo
Scritto da Angela Gennaro in data Novembre 19, 2025
Mariam Dagga, 33 anni, aveva lavorato con l’Associated Press e altre testate a Gaza. La reporter freelance è morta nell’attacco all’ospedale Nasser di Khan Younis, a Gaza, il 25 agosto scorso.
Le parole non sono mai neutre

Yemen, Mawza, 13 December 2018 – A child is sitting near defused rockets. Mawza is located in Taiz governorate, a 45 minutes-drive to the east of Mocha city. This is a very poor and rural area, people are depending on their land to eat and to earn money. The area was taken over from Ansar Allah’s control by forces loyal to President Hadi, supported by the Saudi and Emirati-led coalition, in the beginning of 2018. Fighting damaged the fields and thus, the livelihood of the 13,000 inhabitants of Mawza. While military troops were withdrawing, thousands of landmines and improvised explosive devices (IED) were planted in the area. Between August and December, MSF teams in Mocha received around 150 people injured by landmines or IED, mainly children playing in the fields. Landmines and IEDs are defused by military forces. Local NGOs are in charge of locating these devices.
Non lo sono le immagini (qui quelle di Mariam Dagga).
Non lo sono in politica, non lo sono nel racconto delle migrazioni, e soprattutto non lo sono quando si parla di guerra.
Il linguaggio giornalistico, quando si confronta con la violenza, è costretto a muoversi in un campo minato – a proposito di guerra: ogni parola può contribuire a spiegare, a chiarire, a denunciare — oppure può anestetizzare, distorcere, normalizzare.
Il tema, quindi, non è soltanto linguistico: è etico, professionale e umano.
Le parole sulla guerra non sono mai innocue.
Quello della guerra è un linguaggio ad alta densità emotiva e simbolica.
Le parole che utilizziamo possono rendere comprensibile l’orrore o occultarlo.
Tutte le morti a Gaza, troppo spesso, nel linguaggio giornalistico italiano, soprattutto fino a un certo punto, sono state morti raccontate senza alcuna responsabilità.
Con titoli come: “Nella Striscia morte nella notte 20 persone”.
Come?
Sotto quali bombe? Di chi?
Le parole possono invece delineare una cornice astratta, quasi burocratica.
Espressioni come “danni collaterali”, “bonifica del territorio”, “neutralizzazione del nemico”.
Sono tutte formule che svuotano la realtà della violenza, sostituendo il dolore umano con una semantica tecnica, chirurgica, disumanizzata.
Nel mondo, negli ultimi vent’anni, si è assistito a una tendenza crescente: l’uso di un linguaggio che permette di parlare della guerra senza mai far realmente percepire la guerra.
Nel mondo

Non esiste un racconto neutro della guerra.
Il linguaggio mediatico varia profondamente da un Paese all’altro e riflette spesso la posizione geopolitica, culturale e politica del contesto in cui nasce.
Negli Stati Uniti: nei conflitti post 11 settembre, la stampa ha spesso incorporato il vocabolario dell’industria militare: “operazioni chirurgiche”, “precision strike”, “combattenti nemici”.
Un linguaggio che vuole rassicurare, suggerire controllo, ridurre l’impatto emotivo sulle opinioni pubbliche.
In Italia e in Europa occidentale si osserva spesso una duplicazione del linguaggio istituzionale.
Quando gli organismi nazionali internazionali evitano parole come “bombardamento di civili” e preferiscono “colpiti obiettivi sensibili”, molti media riprendono la stessa scelta lessicale per non apparire schierati.
Ma così non raccontano la realtà
Non esiste un racconto neutro della guerra.
Ma esiste un modo professionalmente onesto di riconoscere questa non-neutralità.
La normalizzazione della violenza

La normalizzazione della violenza avviene quando la guerra smette di essere percepita come eccezionale e inizia a essere assimilata alla routine informativa.
Succede quando le immagini brutali vengono alternate a pubblicità e contenuti leggeri senza contesto.
Quando il linguaggio si ripete in forma stereotipata.
Le vittime diventano numeri
Le motivazioni politiche oscurano la sofferenza umana;
I media si abituano alla violenza e, inevitabilmente, la abituano anche al pubblico.
Quando la guerra viene presentata come inevitabile, “normale”, “parte del mondo”, si produce una forma di rassegnazione.
E la rassegnazione è l’anticamera dell’indifferenza.
Deontologia giornalistica

I principi deontologici fondamentali — verità, accuratezza, completezza, rispetto della dignità umana — diventano decisivi nel racconto dei conflitti.
È necessario nominare la violenza senza edulcorarla
La precisione non è solo un dovere professionale: è un atto etico.
Dire “un ospedale è stato bombardato” è diverso da “è stato colpito un edificio”.
Ed è ancora diverso da “Israele ha bombardato l’ospedale di Nasser a Khan Younis, nella Striscia di Gaza”.
Sono crimini di guerra.
O “gli Stati Uniti hanno bombardato l’ospedale di Kunduz in Afghanistan il 3 ottobre 2015″.
È necessario contesualizzare.
Senza contesto, le notizie diventano frammenti emotivi.
Contestualizzare non significa giustificare, ma spiegare le cause, le responsabilità, le condizioni storiche.
Dare voce alle persone, non solo alle fonti istituzionali, dà conto del fatto che la guerra non è solo geopolitica: è fatta di vite interrotte.
È necessario poi filtrare e verificare il linguaggio delle fonti
I governi in guerra — tutti i governi — hanno interesse a manipolare la narrazione.
La riproduzione acritica del linguaggio ufficiale è una forma di propaganda involontaria.
E rifiutare la spettacolarizzazione
Il dolore non è un contenuto da share.
La deontologia impone misura, distanza, attenzione.
Raccontare la guerra con rigore e responsabilità non significa neutralità, ma prima di tutto onestà.
Potrebbe interessarti anche:
- La crisi dell’ordine globale tra economia e geopolitica
- La crisi della globalizzazione
- Lo sviluppo della globalizzazione
- La guerra dei dazi e la strategia di Trump
E se credi in un giornalismo indipendente, serio e che racconta il mondo recandosi sul posto, puoi darci una mano cliccando su Sostienici