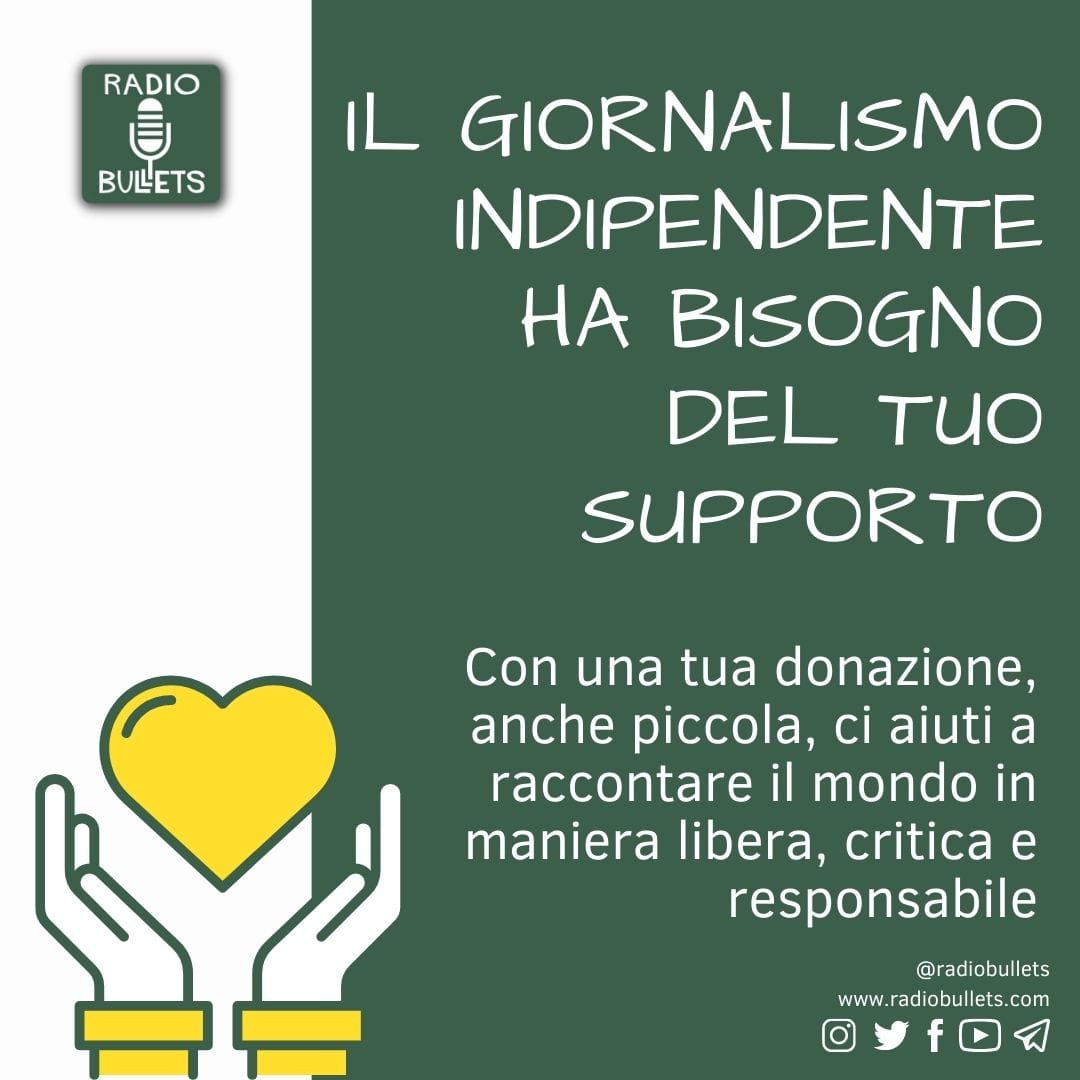La lezione mai imparata
Scritto da Raffaella Quadri in data Agosto 6, 2025
Venti minuti. Bastarono venti minuti per cambiare il destino dell’umanità.
Per farle varcare quel confine sottile che la separa dall’autodistruzione.
Era il 6 agosto 1945 quando il bombardiere B-29 pilotato dal colonnello statunitense Paul Tibbets sganciò nel cielo del Giappone la prima bomba atomica della storia.
Ascolta il podcast
6 agosto 1945: l’atomica devasta Hiroshima
L’impatto dell’esplosione della bomba all’uranio 235 fu micidiale, e la città di Hiroshima fu letteralmente rasa al suolo.
L’esplosione innescata da “Little Boy” – questo il nome che i piloti diedero alla bomba – produsse una potenza di quasi quindici kilotoni, pari all’effetto di quindicimila tonnellate di tritolo.
I calcoli erano stati precisi e tutto andò come preventivato.
Il B-29, battezzato dallo stesso colonnello Tibbets con il nome della madre, Enola Gay, si era levato in volo nelle prime ore di quel 6 agosto da una base statunitense sull’isola di Tinian, nell’arcipelago delle Marianne.
Più di mille chilometri in sorvolo sull’oceano Pacifico lo separavano dal suo obiettivo.
Vi giunse in poche ore, per segnare il destino di Hiroshima alle 8:15 di quello stesso giorno.
La bomba fu sganciata sulla città giapponese.
Non toccò il suolo, ma esplose a poco più di 560 metri di altitudine.
Il famigerato fungo atomico e la potente onda d’urto che si produssero uccisero all’istante ottantamila persone.
Le più fortunate.
Perché nei giorni e mesi seguenti furono migliaia a morire per i terribili effetti delle radiazioni.
In venti minuti, della città giapponese era rimasta una distesa desolata di polvere e morte.
9 agosto 1945: l’ora buia di Nagasaki
Sarebbero passati tre giorni prima che l’orrore si compisse nuovamente.
Protagonista, suo malgrado, un’altra città giapponese.
La prima scelta per l’attacco era stata Kokura, ma le nuvole che ricoprivano la città spinsero il comando statunitense a scegliere un altro obiettivo: Nagasaki.
Di nuovo un B-29, stavolta soprannominato “Bock’s Car”.
Di nuovo una micidiale arma atomica al plutonio, ancora più potente della precedente, cui l’equipaggio diede il nome di “Fat Man”.
Di nuovo una morte atroce per migliaia di civili giapponesi.
Fu così che il 9 agosto 1945, qualche minuto dopo le undici del mattino, nel cielo di Nagasaki ci fu un’esplosione di una potenza di ventidue kilotoni.
Morirono nell’immediatezza dell’attacco circa quarantamila persone.
Nei cinque anni successivi, il computo totale delle vittime sarebbe salito a 340.000.
Armi atomiche: la minaccia infinita
Il messaggio al Giappone arrivò forte e chiaro.
L’imperatore Hirohito, il 15 agosto 1945, dichiarò la resa incondizionata del Paese.
Il secondo conflitto mondiale era giunto al termine.
Ma con un’ultima azione spaventosa e inutile.
Da allora le armi atomiche e le loro devastanti conseguenze – che i giapponesi pagarono a caro prezzo per i decenni a seguire – sarebbero dovuti servire da monito per il mondo intero.
Nessuno avrebbe mai più dovuto utilizzare ordigni atomici.
Nessuno dovrebbe possederne.
Eppure l’uso dell’atomica resta, ancora oggi, dopo ottant’anni da quella immane tragedia, la minaccia più diffusa.
I trattati contro le armi nucleari
Uno degli strumenti per impedire che nuovamente si faccia ricorso ad armi atomiche è il Trattato di non-proliferazione nucleare o NPT (Non-Proliferation Treaty).
Varato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1968, è entrato in vigore nel 1970, per essere poi prorogato a tempo illimitato venticinque anni dopo.
Il trattato è stato firmato da 191 Paesi.
Si pone come obiettivi:
- il contrasto alla proliferazione di armi nucleari
- il disarmo globale
- gli usi pacifici dell’energia nucleare
Tra i 191 firmatari ci sono anche i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che sono dotati di armi nucleari: Cina, Federazione Russa, Francia, Regno Unito, Stati Uniti.
Nel 2017 fu poi adottato, sempre dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari o TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons).
Entrato in vigore nel gennaio del 2021, a oggi, è stato firmato e approvato da 98 Paesi e ratificato da 73.
Si tratta del primo trattato multilaterale sul disarmo nucleare e vieta in maniera esplicita lo stanziamento di ordigni nucleari, anche al di fuori dei propri confini nazionali.
In sostanza, è il primo trattato che effettivamente mette al bando le armi nucleari.
«Gli armamenti nucleari pongono pericoli crescenti e al mondo occorre un’azione urgente per garantirne l’eliminazione e scongiurare le catastrofiche conseguenze umane e ambientali che deriverebbero dal loro utilizzo» ha dichiarato in occasione dell’entrata in vigore del trattato nel 2021 il Segretario generale dell’ONU António Guterres.
«L’eliminazione delle armi nucleari rimane per le Nazioni Unite la massima priorità in tema di disarmo».
Il progetto Manhattan
La bomba atomica nasce dalla ricerca scientifica condotta attraverso, soprattutto, il Progetto Manhattan.
I primi studi ed esperimenti, però, furono avviati in Germania alla fine degli anni Trenta, quando fu realizzata la prima fissione del nucleo dell’uranio.
La scoperta della fissione e di una così potente fonte di energia avrebbe aperto la strada allo sviluppo di studi ulteriori per il suo utilizzo per scopi civili, ovvero per produrre energia.
Tuttavia, le implicazioni belliche furono inevitabili.
Anzi furono il primo scopo della ricerca.
Intento che spinse gli Stati Uniti ad avviare il Progetto Manhattan.
L’idea era di sfruttare le potenzialità della fissione per usi militari.
Un obiettivo – si sarebbe scoperto pochi anni più tardi – drammaticamente centrato.
Il programma per la costruzione della bomba atomica prese il via nel 1940 e fu condotto da scienziati americani e da un gruppo di scienziati europei fuggiti dal regime nazista.
Al progetto prese parte anche il fisico italiano Enrico Fermi, che fu uno dei suoi direttori tecnici.
Il 2 dicembre 1942 presso l’università di Chicago, un gruppo di scienziati, guidati proprio dal fisico italiano, riuscì a verificare la potente fonte di energia sprigionata dalla fissione nucleare.
Il gruppo realizzò la prima reazione nucleare a catena controllata. Preludio allo sviluppo dell’energia nucleare.
Il 16 luglio 1945 fu condotto il “Trinity test” nel Nuovo Messico, dove fu fatta detonare la bomba al plutonio.
Erano le prove generali di quanto, di lì a poco, sarebbe accaduto a Hiroshima e Nagasaki.
La via del non ritorno
Nonostante il Trattato di non-proliferazione, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari e la consapevolezza che una guerra atomica avrebbe conseguenze devastanti e irreparabili, la minaccia del ricorso alle armi nucleari incombe a tutt’oggi sui contrasti in corso in diverse parti del mondo.
Una minaccia più che mai reale e che pone l’esigenza di fare ogni passo possibile perché non ci si incammini su quella che sarebbe, senza dubbio, la via del non ritorno.
Musica: “Theme For Sarah” – Brilliant Sky (Audiio)
Foto in copertina: Hitesh Choudhary – Pixabay
Ascolta/Leggi anche:
- Tecnologia di guerra
- Fusione nucleare: i piani del G7 nel primo Working Group
- Alla ricerca di una nuova energia nucleare
- Tic Tac: la mezzanotte del mondo
- L’industria degli armamenti e il complesso militare-industriale
- Scacco alla scienza
- Afghanistan: Donne rimpatriate e cancellate
- Israele uccide altri sei giornalisti
- Quali sono i paesi peggiori in cui vivere nel 2025?
E se credi in un giornalismo indipendente, serio e che racconta il mondo recandosi sul posto, puoi darci una mano cliccando su Sostienici