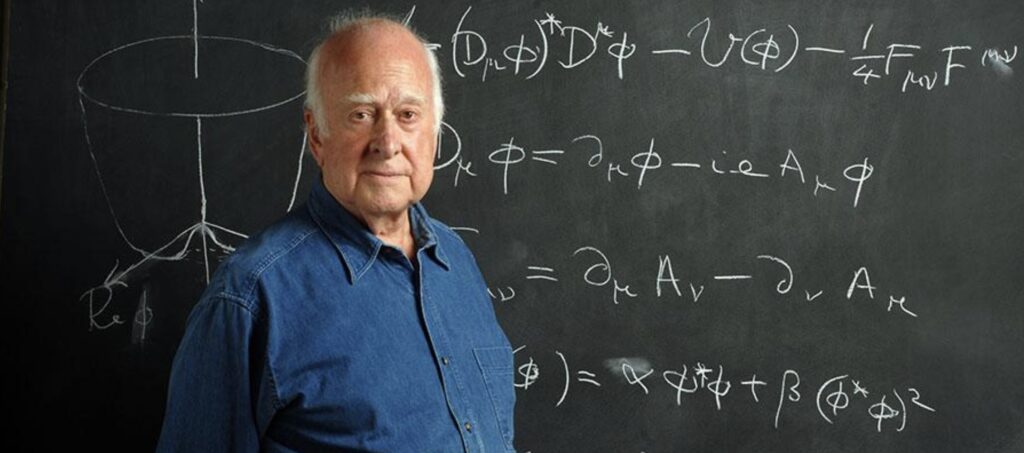Babati: fritto e polvere
Scritto da Eleonora Viganò in data Gennaio 24, 2019
Babati è la mia libertà. Ci arrivo dopo essere stata sul Kilimanjaro e dopo aver conosciuto Syia durante il mio giorno e mezzo di Safari – in luoghi somiglianti a quelli tipici dell’immaginario collettivo: ampi spazi, terra, giraffe e zebre, gnu che migrano e il suolo del cratere Ngorongoro che crea molteplici colori di verdi e marroni se visto dall’alto – ci arrivo spinta dal desiderio di voler vedere i dipinti rupestri di Kolo, vicino a Kondoa: un punto al centro della Tanzania.
Eleonora Viganò per Radio Bullets.
Babati è una città di passaggio durante una prima parte in cui viaggio velocemente, eppure in quel poco tempo trascorso lì, ho conosciuto Emmanuel e Paschal, due giovani ragazzi ben disposti ad aiutarmi e a tradurre per me. Il primo lavora friggendo patatine e pollo sul ciglio della strada, mi procura un biglietto del bus per Kolo e Mwanza e mi fa assaggiare il pesce cucinato con le banane. Mi dice che vorrebbe diventare guida turistica e smetterla di cucinare, anche se i suoi piatti sono migliori rispetto alla concorrenza che si dipana lungo tutta quella strada asfaltata, quella arteria principale e senza luce che divide a metà la terra polverosa di Babati. Paschal, invece, è ancora più giovane: va a scuola, ha la camicia inamidata e lavora in un negozio di tecnologia per aiutare la madre. Lo aspetta a cena, eppure decide di accompagnarmi a un bancomat per prelevare. Babati – con la sua stazione piena di vita, terra, colori, rumori, odori e sapori – è stata un appoggio semplice, accogliente e rigenerante: l’ho vista per due sere, due mezze giornate scarse, eppure la ricordo come una città che sa di cose buone, ovviamente fritte.
Syia mi saluta e mi carica su un autobus diretto a Babati: è da lì che poi, il giorno seguente, sarei andata a Kondoa per vedere i dipinti rupestri – situati in realtà a Kolo, poco distante dalla città di Kondoa –, meta fortemente desiderata fin da quando ho iniziato a preparare il viaggio. Sempre che si possa dire: “preparare”. Mi ricordo un giorno di gennaio, mentre parlo tra me e me ad alta voce:
Ah! A Kondoa ci vado sicuro.
Scorro il dito, lì intorno: ecco, in Tanzania centrale ci sono pochi turisti e niente safari idioti.
Ah sì, anche qui: Selous e Ruaha. Poi ci sono Mafia e Kilwa.
Riassumendo: visito la Tanzania settentrionale, ché sono a già a nord per il Kilimangiaro, poi centro e poi sud e poi ritorno a nord passando per la parte orientale.
Hai un mese, non due anni.
Allora settentrionale e centrale. Ecco.
Ma il sud? No, dai: anche il sud è interessante.
Il lago Tanganika, invece, dove sta?
A ovest.
Di tutto ciò che avrei voluto vedere rimane molto meno: compirò scelte, farò variazioni, aggiustamenti e rinunce. Il Tanganika, forse la parte – secondo le guide – più selvaggia, resterà un desiderio inesplorato. È da questo lago (e dalla regione chiamata appunto Tanganika) e da Zanzibar, che prende il nome l’intero Paese: un’unione tra Tanganika e l’isola di Zanzibar, una repubblica a sé, che richiede quindi il passaporto a portata di mano. Tanzania.
Ma torniamo al bus, in piedi tra la folla di passeggeri: salgono alcuni Masai senza biglietto. La coppia di bianchi è seduta. Quando ci parlo, all’arrivo, lei mi dice che fra poco tornerà a casa, in Canada e non vede l’ora. Il fatto che rimanga stupita che io sia a Babati, dove i turisti solitamente non transitano, mi fa sperare in una buona scelta. In realtà Babati è una qualsiasi città caotica, della quale ho apprezzato solo le arterie principali: in questa prima fase del viaggio ho corso, restando poco nei luoghi, per qualche strano timore e perché – forse – dovevo ancora abituarmi a un viaggiare lento e imprevedibile. Per esempio, secondo Syia avrei dovuto farcela per un bus per Kondoa, in modo da dormire direttamente lì e magari fare un salto, dopo le pitture rupestri, anche a Dodoma, capitale del Paese. In realtà siamo arrivati che era già quasi buio, a Babati. L’alloggio che trovo, grazie alla canadese, è pulito e semplice. Non è in centro ma devo imboccare alcune vie sterrate che si immettono nella strada principale. Ci sono locali, baretti, chioschi all’aperto sul ciglio della strada. Mi perdo, in una delle mie prime esplorazioni della città. In un negozietto di tecnologia, al quale mi reco disperata dopo aver scoperto di non riuscire a prelevare, conosco Paschal, un ragazzino giovanissimo che va a scuola e lavora per aiutare sua madre. Quella sera lo aspetta a cena, ma lui decide di accompagnarmi al bancomat. La zona che di Babati conoscerò di più è lo spiazzo polveroso della stazione degli autobus, intorno alla quale ruota e si muove tutto, la vita, direi. Intorno alla stazione ci sono negozi, baretti per la colazione, rivenditori di biglietti per le varie destinazioni, qualche sarto, un negozio di telefonia Vodacom, un tavolino ingombro di libri e le teche con i samosa e le ciambelle fritte. In mezzo c’è un via vai continuo di venditori ambulanti, procacciatori, colori e rumori fortissimi. La terra. È la terra a rendere tutto diverso. I sapori: i sapori di fritto, di chapati e samosa, di pesce cucinato con le banane. Il disordine, ovviamente.
La zona del mio ostello è invece silenziosa e quasi spettrale, soprattutto di sera e soprattutto la mattina in cui partirò per Mwanza, all’alba. Avvicinandomi al centro nevralgico: a quell’unica strada asfaltata che sembra dividere come un coltello le due parti brulle e brulicanti di Babati, rigorosamente sprovviste di lampioni, avvicinandomi lì si intensificano i luoghi di ritrovo, i colori, gli odori di cibo fritto e la musica, ovviamente.
Emmanuel lo conosco perché ho bisogno di fare un biglietto per Kondoa, che poi sarà Kolo, ma al momento non ricordo proprio come ho fatto farmi capire e a capire dove avrei dovuto scendere. Forse perché è l’unico luogo vagamente turistico della zona. Sono in mezzo alla piazza: non è proprio un essere al centro, visto che il caos sposta il centro di volta in volta a un bus, a un venditore oppure a una qualsiasi attrazione del momento. Il centro è mobile e io – bianca, anzi mzungo – sono spesso questo centro. Mzungo non significa letteralmente “bianco”: i cinesi, per esempio, non sono tali perché sono lì per affari. Il colore della pelle non c’entra: il mzungo è bianco ma è anche lì per spendere. È un turista. Emmanuel mi parla in inglese: ha lunghi rasta, i colori della Giamaica addosso e vestiti comodi. È basso e magrolino e potrà avere sì e no 20 anni. Mi porta davanti a una porta con un tavolino: dietro al tavolino c’è un uomo. Emmanuel e l’uomo si parlano e ovviamente non so cosa si dicono. Emmanuel mi traduce, mi dice quanto devo pagare, mi dice orario e luogo per l’indomani, ché sul biglietto l’ora è diversa e non ci si capisce niente. Mi fa promettere che andrò da lui a cena, proprio là, nel baracchino sull’angolo, quello che dà sulla strada asfaltata senza lampioni.
Dopo una doccia, un giro veloce e qualche acquisto, torno da Emmanuel: glielo avevo promesso e al momento è anche il solo contatto che ho. Ci tornerò anche la sera seguente, quando mi aiuterà insieme a Paschal con il biglietto per Mwanza, dicendomi che vorrebbe studiare come guida e smetterla di friggere patatine. Io passo le mie due serate a quel tavolino di plastica: ricordo un via vai di gente, la concorrenza lungo un bel pezzo di strada, una famiglia accanto a me e una bambina che mangiava avidamente le sue patatine con il pollo.