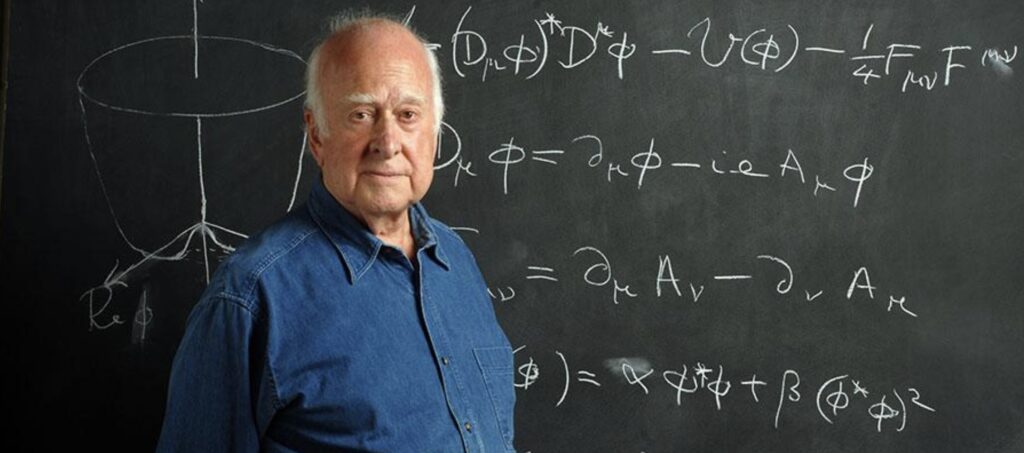We are who we are – La recensione
Scritto da Teresa Soldani in data Novembre 3, 2020
Si sono appena conclusi su Sky Atlantic, il 30 ottobre – con qualche giorno di anticipo rispetto alla programmazione americana sulla HBO – gli 8 episodi della serie “We are who we are”, primo esperimento televisivo di Luca Guadagnino che ha creato, diretto e scritto lo show con Paolo Giordano e Francesca Manieri, che ne hanno firmato con lui la sceneggiatura.
Invece di leggere, ascolta il podcast per un’esperienza più coinvolgente
Recensione senza spoiler
La serie – che vi consigliamo caldamente di recuperare nel caso l’aveste persa – racconta l’estate di un gruppo di adolescenti che vivono, o comunque hanno stretti contatti, con una base militare americana situata a Chioggia, in Veneto, e inizia con l’arrivo del quattordicenne Fraser (Jack Dylan Grazer) in Italia, assieme alla madre biologica, il colonnello Sarah Wilson (Chloë Sevigny), nonché nuovo comandante della base, e la moglie di lei, Maggie, interpretata da Alice Braga.
Sin dalle prime battute è evidente che Fraser è un ragazzo problematico, in conflitto con le madri per averlo estirpato dalla sua vita a New York e costretto ad andare in un paese di cui non conosce la lingua e che è lontano anni luce dal mondo dal quale proviene. La sua prima giornata nella base − descritta nella première, e che si concluderà con una sonora sbronza − lo vede infatti girare senza meta per Chioggia, dove incontrerà Britney (Francesca Scorsese), che lo introdurrà poi in quello che diventerà il suo gruppo di amici.
Uno degli aspetti che suscita maggiore curiosità di questa serie è il fatto che sia stato proprio un regista italiano a sfruttare il potenziale di raccontare storie di un gruppo di adolescenti che vivono nelle basi americane all’estero, scelta che – in un certo senso – ha anche permesso allo show di non essere riempito di cliché o, se ci passate l’espressione, di “americanismi” su “Dio, patria ed esercito”, di cui solitamente produzioni di serie o film americani, ambientate in questo mondo, sono infarcite. La mano di un autore non americano è infatti piuttosto evidente, il che non è assolutamente un male, come non lo è per il modo in cui viene anche rappresentata l’Italia, ben lontana dagli stereotipi con cui viene mostrata fin troppo spesso oltreoceano.
Per contro, è difficile capire se la serie catturi davvero la vita dei militari americani e delle loro famiglie all’estero (anche se va detto che lo scopo dello show non è certo quello). Ciò nonostante, è evidente la cura di alcuni dettagli, come quando Britney spiega a Fraser come i prodotti all’interno dei supermercati di tutte le basi americane nel mondo siano distribuiti esattamente nello stesso modo, per far sentire i militari a casa.
Tornando al protagonista, Fraser − con i suoi capelli ossigenati, le unghie dipinte e soprattutto l’atteggiamento strafottente e a volte persino aggressivo − non è il tipico protagonista di una serie televisiva a cui ci si affeziona sin dalle prime battute. Il suo modo di fare, soprattutto nei primi episodi, provoca, al contrario, una certa istintiva antipatia, la stessa che si può provare di fronte alla noncuranza di un qualsiasi adolescente.
In una particolare scena, per esempio, Fraser schiaffeggia per una sciocchezza la madre Sarah, con cui ha uno strano rapporto di amore e odio, quasi edipico, che crea peraltro una forma di discordanza nel personaggio interpretato dall’attrice: una donna in una posizione di indubbio potere che sembra però trasformarsi in un’altra persona nella sua relazione disfunzionale con il figlio.
Quando Fraser incontra la sua vicina Caitlin (interpretata da Jordan Kristine Seamón), detta Harper, tra i due nasce un’immediata affinità elettiva, per ragioni che non saranno immediatamente comprensibili, come se – istintivamente – i due ragazzi si fossero riconosciuti per una qualche misteriosa trama del destino.
Ed è qui che la serie acquisisce una delle sue caratteristiche più stimolanti, soprattutto dal punto di vista della sceneggiatura, perché “We are who we are” è strutturata in maniera molto particolare, come se a contare non fossero tanto gli eventi o la linearità della trama, quanto piuttosto le sensazioni provate dai protagonisti durante giorni scanditi dalla canicola di un’estate italiana, vissuta senza troppe preoccupazioni e pensieri. Il che è anche uno degli aspetti che fa in un certo senso assomigliare lo show a “Chiamami col tuo nome”, oltre ovviamente al modo in cui esplora l’identità sessuale dei suoi protagonisti.
In questo approccio narrativo − che permette ai personaggi di vivere una vita che non sembra scandita dal tempo − finisce per irrompere talvolta la realtà in maniera del tutto marginale, come se avesse importanza solo ai fini della maturazione dei personaggi e non come una cosa a sé stante. La serie, per esempio, si svolge nel 2016 durante le presidenziali in cui fu eletto Trump, ma lo capiamo solo grazie ad alcuni estratti di telegiornali americani che vengono mostrati come sottofondo in molti degli schermi sparsi per la base.
La politica stessa − anche quando appare molto collegata ai diritti LGBTQ che hanno molto a che fare con questa serie − è comunque trattata come un qualcosa di marginale, a meno che non serva per inquadrare meglio un personaggio, come accade per esempio con il padre di Harper, interpretato dal rapper Kid Cudi, che all’inizio sembra un uomo premuroso e molto legato alla figlia, ma che nel prosieguo del racconto cambia completamente volto.
Man mano che la storia evolve, infatti, tra i due cominciano a crearsi delle evidenti crepe le cui avvisaglie sono anticipate da una scena in cui lui regala alla figlia un cappello rosso MAGA, che è l’acronimo di “Make America great again” (facciamo di nuovo grande l’America), l’ormai famoso slogan usato da Trump e dai suoi elettori.
Una Harper che sta faticosamente esplorando la sua sessualità, non potrebbe mai essere rappresentata dai principi dell’America conservatrice di cui Trump si fa portavoce, sebbene la cosa importante nella serie non sia dare giudizi di merito sulla politica, quanto piuttosto cogliere di sorpresa il pubblico mostrando quanto diversi siano padre e figlia, nonostante l’iniziale impressione che potevamo aver avuto di loro.
L’elemento sorpresa
L’elemento sorpresa è infatti un’altra caratteristica di questa serie, che sfida continuamente i confini e si rifiuta di essere categorizzata. Abbiamo militari abituati alla disciplina e al rigore che diventano genitori eccessivamente permissivi, e una generale tendenza al rifiuto di tracciare linee precise, anche e soprattutto quando si affronta il tema della sessualità, compresa quella del protagonista che non accetta le convenzioni e la norma e vuole essere solo sé stesso, con tutta la confusione della sua età, proprio come se anche l’ambiguità fosse essa stessa una scelta.
In un’era in cui è sempre più difficile spiegare un concetto senza offendere qualcuno, in cui sembrano esistere solo il bianco e il nero, il giusto e lo sbagliato, è con un certo sollievo che ci si perde nelle sfumature di grigio di questa serie.
Sebbene i protagonisti della storia siano indiscutibilmente gli adolescenti, “We are who we are” non dimentica comunque gli adulti. Oltre alla madre di Fraser e al padre di Harper, ai quali abbiamo già accennato, spiccano per esempio i personaggi di Jenny, la madre di Harper e Danny − nigeriana ed ex musulmana convertita (per necessità, più che per scelta) − e Maggie, la seconda madre di Fraser. Le due rappresentano in un certo senso una categoria di persone che vorrebbe avere la stessa joie de vivre dei figli, la medesima incoscienza e impulsività, ma che – a differenza loro – devono fare i conti con le responsabilità della vita adulta e con le conseguenze delle loro scelte.
Nonostante questa serie si faccia portavoce del frustrante egoismo che spesso caratterizza gli adolescenti, che sembrano vivere senza una preoccupazione al mondo, questo show non vuole scioccare come fa per esempio “Euphoria”, sempre della HBO.
Dal punto di vista della fotografia e della regia, poi, questa è anche una serie palesemente lussuriosa − non solo in senso stretto − per l’abbondanza dell’uso della nudità sia femminile che maschile (piuttosto rara in TV e che rappresenta ancora un tabù), sicuramente non in un’accezione voyeuristica del termine, ma anche per il modo in cui a Guadagnino – sulla sedia della regia − piace soffermarsi sui dettagli con sensuale pigrizia, come se avesse tutto il tempo del mondo, proprio come i protagonisti della storia che racconta.
“We are who we are” è uno show che può provocare qualche resistenza da parte del pubblico, eppure ha qualcosa da dire e lo fa rifuggendo cliché e regole: anche solo per questo meriterebbe di essere guardato.
Anche questo episodio di Terevisione è giunto al termine, ma prima di lasciarvi, vi anticipiamo che la prossima settimana parleremo della 4° stagione di “The Crown”, che andrà in onda su Netflix a partire dal 15 novembre, mentre nei podcast successivi, inizieremo un breve viaggio “dietro le quinte” delle serie TV, parlandovi di come si arrivi da un’idea alla produzione di uno show televisivo americano.
Se avete domande o commenti non esitate a contattare Radio Bullets sui social e vi risponderemo.
Ti potrebbe interessare anche:
- Animazione e pandemia
- Le passage
- Come sono cambiati i set televisivi a causa della pandemia
- Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sessuale dai conflitti
- Etiopia: sull’orlo della guerra civile
- Dormire in un mare di stelle
E se credete in un giornalismo indipendente, serio e che racconta recandosi sul posto, potete supportarci andando su Sostienici