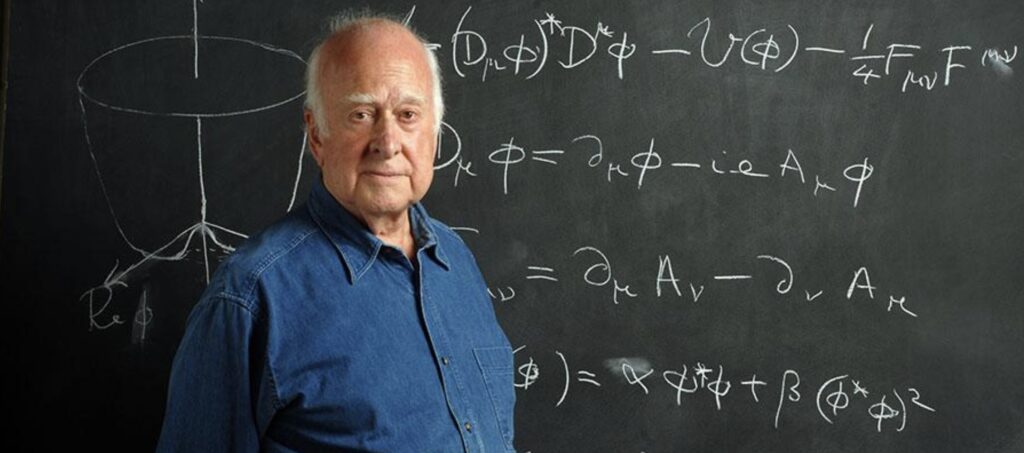Un pranzo di Natale (quasi) perfetto
Scritto da Eleonora Viganò in data Agosto 15, 2019
Non mi sono preparata per niente per il cammino in Israele e Palestina: ero convinta che bastassero tre guide cartacee, una bussola, ricerche in internet, una sim israeliana e google maps. In realtà avrei dovuto studiare un percorso definito, capire le strade, controllare soprattutto il meteo e utilizzare le pochissime informazioni a disposizione, anziché fare di testa mia. La prima tappa è stata un fallimento: sono stata troppo tempo ad Akko, sono arrivata a Iblin e l’accoglienza era chiusa, ho percorso 50 km perdendomi ripetutamente e chiedendo un paio di passaggi. Alla Vigilia di Natale ero tra le luci – il freddo e la pioggia – di Nazareth.
A cura di Eleonora Viganò su Radio Bullets
Prima di partire
Tre guide per un paese grande quanto la Calabria, mappe indecifrabili, una bussola e applicazioni con il gps: pensavo di essermi equipaggiata al meglio per affrontare un viaggio a piedi attraverso un territorio sconosciuto e senza segnaletica. Sarei partita da Akko, in Israele, il 24 dicembre – Acri, in italiano, ma ben presto avrei capito che ogni città ha almeno tre pronunce differenti – per arrivare a Gerusalemme il 31 dicembre. L’idea era di seguire un percorso che toccasse i principali luoghi della tradizione cristiana: Nazareth, il Monte Tabor, Tiberiade, Cafarnao, Gerico. È una continuazione della Via Francigena in Italia (che parte da Canterbury e arriva a Roma per poi proseguire al sud fino a Brindisi) e uno dei tre pellegrinaggi sacri per la cristianità, insieme al Cammino di Santiago.
La preparazione è stata complessa e allo stesso tempo trascurata da parte mia. Avevo raccolto informazioni sul territorio e preso in considerazione gli altri trekking israeliani, soprattutto il National Trail, per capire se vi fossero alternative segnalate e paesaggisticamente interessanti. L’Israel National Trail è il migliore (e uno dei miei prossimi desideri) ma copre un percorso di più di 900 km: per me farne solo un pezzo in 20 giorni avrebbe avuto poco senso. Inoltre, le città che avrei voluto visitare erano deviazioni al tracciato originale (Nazareth e Gerusalemme, per esempio) e non sarei riuscita a toccarle tutte nel tempo a disposizione. Partii sapendo di non essere pronta ma convinta di aver fatto il possibile. Mappe, sim israeliana, batterie esterne e bussola erano solo palliativi, anche inutili.
Akko, Walid e le strade per Nazareth
Il primo errore l’ho commesso subito: il giorno seguente al mio arrivo, il 23 dicembre, ho voluto visitare Akko, anche se mi era stato detto che la sola accoglienza presente a Iblin avrebbe chiuso per le festività natalizie a partire dal 24 dicembre. Proprio la notte in cui avevo previsto il mio arrivo nel villaggio arabo. Ne parlai con Walid, il gestore del mio ostello: sarebbe stato possibile andare direttamente a Nazareth, accorciando la strada. Scegliendo di passare da Iblin rischiavo di non trovare alloggio e di allungare eccessivamente (50 km in tutto) in caso avessi dovuto per forza proseguire per Nazareth. L’alternativa non mi convinse e decisi di proseguire per Iblin
Walid, un uomo robusto, un arabo israeliano segnato dalle rughe e stempiato, aveva voglia di parlare con i suoi ospiti soprattutto di religione e politica, insieme a un suo caro amico, forse cristiano. Mi ricordo solo una frase netta e distinta: io sono sempre stato qui, i miei antenati sono sempre stati qui ed è Israele che è arrivato da me. A fargli compagnia nelle discussioni serali ci fu una donna tedesca di mezza età, mentre io me ne stavo in silenzio ad ascoltare e a osservare. Avevo trascorso il primo giorno ad Akko vedendo e rivedendo le stesse cose più volte, favorita dal tepore della giornata: prima da sola e poi con un uomo improvvisatosi guida. Un pescatore mi fece accomodare su una seggiola di plastica nella sua bottega, mi offrì un caffè arabo e mi mostrò pesci appena pescati in attesa di essere pesati. Walid quella sera ripassò con me le varie opzioni, le strade e le possibilità, toccandosi spesso la barba ispida, corta e poco curata. Me la caverò, gli dissi. Il 24 mattina partii poco prima dell’alba con Google Maps acceso, gli occhi che si spostavano dal cellulare alla strada, lo zaino pesante. Un uomo che faceva jogging in direzione opposta alla mia mi chiese se stessi andando a Gerusalemme e mi augurò buon viaggio.
Ero in cammino.
Il pranzo di Natale
Quel giorno attraversai campi, chiesi molte indicazioni a gente incredula, oltrepassai un kibbutz camminando per le sue stradine interne. Ero tesa nonostante fossero pochi km, fossi partita presto e avessi la situazione sotto controllo. Non vidi nessuno per molto tempo, finii anche l’acqua e non avevo fatto colazione. Arrivai a sei km da Iblin quando un gruppo di quattro uomini mi chiamò con cenni e voce. Stavano all’interno di una specie di maneggio, seduti su seggiole di plastica bianca a conversare – di cosa non saprei dirlo, non conoscendo l’arabo – e si interruppero quando la mia presenza tra quelle stradine infangante e isolate li incuriosì. Mi fidai. Ero stanca e avevo voglia di riposare, anche se il navigatore mi diceva che mancava davvero pochissimo, che sarei arrivata per le 11.00: in tempo per trovare un alloggio o decidere di proseguire. Era il 24 – dicevamo – la vigilia di Natale. Ero affamata e preoccupata. All’inizio mi sedetti e basta, sorridendo e cercando di comunicare in inglese. Poi accettai quello che per me fu il più bel pranzo di Natale al quale abbia mai partecipato. In un attimo approntarono un tavolino basso e scalcinato, portarono i piatti, aprirono un vaso di hummus, ci misero sopra l’olio senza risparmiarsi. Al centro c’erano pane e verdure: cetrioli, pomodori e peperoncini verdi. Il caffè era già rimasto a decantare a sufficienza nella loro brocca coperta. Prepararono le uova e mi offrirono con gesti fermi ogni pietanza. I cavalli poco distanti stavano nelle loro recinzioni. Spiegai la mia situazione ma parlammo davvero poco, intenti a osservarci e a gustare il cibo. Vollero una foto con me e mi accompagnarono in auto a Iblin perché ormai si era fatto tardi per percorrere quel tratto a piedi.
Iblin
Mi lasciarono all’inizio del villaggio. Mi sentii come se per un istante ci fosse stato un fermo immagine. Una pausa forzata. Avevo assaporato il contatto e la relazione e ora ero di nuovo sola, in un villaggio di sicuro non turistico e senza alloggi per la notte. Dopo qualche istante mi riallacciai per bene lo zaino e andai a cercare qualcuno. Una persona in un negozio, un passante, il proprietario di un bar: chiunque avrebbe potuto offrirmi una stanza. Perché alla fine ero certa che lì, a Iblin, l’accoglienza era chiusa e lo sapevo da mesi prima. Fui fortunata: il secondo al quale chiesi mi rispose. Mi rispose in arabo. Stava in un negozio vuoto, probabilmente ancora chiuso. A memoria mi sembra di ricordare un bancone come di una macelleria ma no: era tutto freddo, bianco, impersonale. Solo una bambina di circa otto anni – seduta su una piccola seggiola rosa – dava un senso a quel luogo. Era la figlia dell’uomo che mi rispose a gesti, a suoni incomprensibili (più tardi, continuando a sentire il suono bayt capii che significava “casa”) offrendomi un posto in cui stare. Salii sulla sua auto con la figlia, arrivai al suo appartamento, mi tolsi le scarpe e mi lasciai spiegare ogni cosa: dove dormire, la doccia, il bagno, la stanza della figlia, la cucina e il frigorifero. Si preoccupò di dirmi di mangiare e mi diede istruzioni anche per quello – sempre in arabo, ovviamente – ero assonnata e sudata. Mi sfiorò il viso con le dita per salutarmi e poco dopo capii che non aveva inteso che sarei rimasta solo per una notte. Il cellulare era spento e scarico. Io mi accorsi che tra le stanze da letto non c’erano porte. Andò al lavoro e mi lasciò lì con la figlia. Non mi passò in testa di verificare se vi fosse una presenza femminile adulta: abiti, accessori, cosmetici… semplicemente non la percepii e non riuscivo a convincermi che sarebbe stata una buona idea fermarmi. Scrissi ad alcuni amici in Italia, pensai velocemente per non perdere tempo: era il 24 dicembre, forse sarebbe stato meglio stare a Nazareth. Acciuffai lo zaino, rimisi le scarpe, fissai la doccia con un ultimo sguardo lascivo e dissi alla bambina che non potevo restare. Quando aprii la porta mi trovai di fronte lui e senza scompormi gli dissi che dovevo andare a Nazareth. Ci rimase male e voleva darmi un passaggio fino alla fine di Iblin. Andai avanti per la mia strada e dopo poco accettai: mi lasciò su una stradina sterrata raccomandandomi di andare sempre dritta, sempre. Quella sera mi chiamò per chiedermi se fossi arrivata: da allora non mi ha più cercato. Da Iblin a Nazareth fu un continuo andare su e giù: a volte google map mi permetteva di proseguire senza pensieri, altre volte perdevo la traccia e con essa la mia sicurezza. La richiesta di indicazioni per Nazareth lasciava stupefatti e spesso era incomprensibile, per via di una pronuncia sbagliata. Attraversai i paesi dei beduini e mi fermai in qualche casa quando la richiesta di informazioni si trasformava in inviti a sedermi, bere, conoscere la famiglia e mangiare qualcosa. Il mio zaino si riempì di frutta e io ero colma di gratitudine, anche quando rifeci lo stesso giro due volte, spaventandomi all’idea di essermi persa tra un’autostrada e un bosco o quando un tizio mi diede un passaggio fino a una fermata del bus pur essendo shabbat e sapendo che non ne avrei visti, di bus. Da ultimo mi arresi alla pioggia che stava arrivando e all’assenza di punti di riferimento.
L’arrivo a Nazareth, in jeep
Due ragazzi di poco più di vent’anni mi diedero un passaggio fino alla città. Non entrai a Nazareth a piedi, non dissi: “no, non vi preoccupate, lasciatemi qui”. Ero stanca, sporca, con un’ansia accumulata fin dalle prime ore del giorno. Lo zaino viola e il kway rosa erano umidi delle prime gocce, gli scarponcini avevano tracce di fango. Il cellulare mi rimandava sempre su una strada troppo larga e trafficata e i ragazzi avevano chiamato un loro amico tedesco con il quale io potei parlare per spiegare bene cosa ci facessi lì. Abbandonai qualsiasi cocciutaggine e accettai il loro aiuto. Mi misi comoda sul sedile posteriore della jeep e sorrisi, anche quando restammo imbottigliati in coda. Nazareth – la vigilia di Natale – è una sola luce colorata e luminosa, dall’aria gelida – acquistai un cappello di lana e un paio di calzettoni – folla e mercato si confondevano insieme a chi festeggiava intonando canzoni. Ci sono stati fuochi d’artificio, visti da un vicolo stretto accanto al mio ostello. A Natale visitai Cana, la moschea, la chiesa ortodossa e il Monte Tabor, accompagnata dalla tedesca che gestiva il mio ostello e che mi mise in guardia: “non è stagione di cammini, questa. Piove e pioverà”, mi disse. Nazareth mi lasciò solo tristezza addosso. Passai la sera del 25 dicembre scrivendo le ipotetiche tappe su un quadernino color carta da zucchero: avevo con me la guida, internet per gli ostelli, una coperta e la borsa dell’acqua calda e mi stavo convertendo a una sana felicità. Quella della viaggiatrice.
Ascolta o leggi anche:
- Se vi interessano le ultime notizie dal Venezuela o gli editoriali di Barbara Schiavulli, non vi resta che andare su Parole Scompigliate
- Gli approfondimenti di Sportcast ma anche sulle serie televisive con Giuliano Terenzi
- La rubrica Technomondo, con le più curiose e interessanti novità di scienza e tecnologie, raccontate con passione da Raffaella Quadri
- Marighella. Mariangela Matonte racconta il biopic sugli ultimi anni di vita e di guerriglia politica di Carlos Marighella, simbolo della resistenza armata alla dittatura militare che ha oppresso il Brasile per oltre vent’anni
- Palestina, Amnesty contro Israele: “Sistematici sgomberi forzati”
- Appello Onu per gli ivoriani bloccati in Tunisia
- I bambini del Caucaso
- Varcare confini, costruire muri
- Iran, scrivono “No all’apartheid di genere”: arrestate
- La Tunisia è in difficoltà per trovare luoghi di sepoltura per le decine di migranti annegati che vengono recuperati dal mare
E se credete in un giornalismo indipendente, serio e che racconta dai posti, potete sostenerci andando su Sostienici